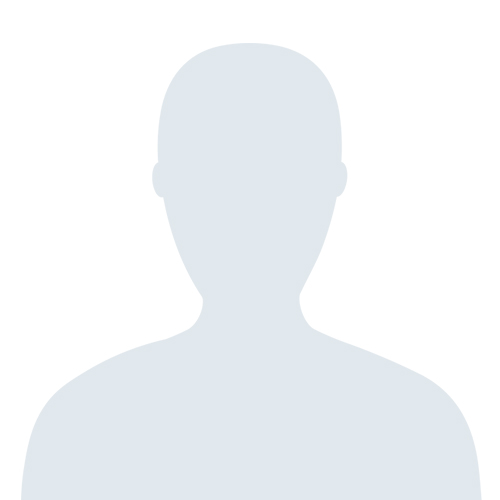Professore al Politecnico di Milano, alla Parsons School di New York, alla Tonji University di Shanghai, Ezio Manzini si occupa da più di 20 anni di design per la sostenibilità. Autore di molte pubblicazioni, ha diretto diverse ricerche nazionali e internazionali, ricevendo numerosi riconoscimenti e premi sia in Italia che all’estero. Recentemente i suoi studi si sono focalizzati più sui temi legati all’innovazione sociale, considerata una dei principali motori dei cambiamenti sostenibili. Ha fondato e coordina Desis, una rete internazionale di scuole di design e di organizzazioni attive nel campo del innovazione sociale e della sostenibilità.
Professor Manzini, nel 2003 avete presentato una mostra che si intitolava Quotidiano sostenibile: Scenari di vita urbana, com’è cambiato da allora il nostro “quotidiano sostenibile”?
La mostra per noi è stata un punto di partenza, vista con gli occhi di oggi può anche sembrare un po’ ingenua. Tuttavia ha anticipato alcune tendenze. In Italia e in altre parti del mondo sono fiorite idee e servizi che prevedono forme di collaborazione tra chi utilizza e chi organizza. Questo fenomeno si può osservare un po’ in tutti i settori: nell’alimentare, per esempio, che è forse l’ambito dove sono successe le cose più evidenti (dal chilometro zero ai mercati dei contadini, ai gruppi di acquisto), nella mobilità (il car sharing è ora piuttosto diffuso, il car pooling fa più fatica a svilupparsi però qualcuno lo pratica, l’uso condiviso delle biciclette sta cambiando il volto dei centri storici di molte città), fino al sistema abitativo in cui l’idea del collaborative housing sta passando dalle defunte comunità hippy a qualcosa di cui è più facile parlare anche con persone meno impegnate ideologicamente.
Un concetto, quello che all’origine dei servizi collaborativi, che si sta sviluppando non solo in paesi maturi ma anche, sotto forme diverse, in nazioni come Cina e India, e che ha come tratto comune la rottura di quell’individualismo impazzito che ci è stato proposto fino a qualche anno fa, e la scoperta che se si collabora si ottiene un aiuto pratico, si risparmia, e ci si sente un po’ meno soli.
C’è chi racchiude queste idee e servizi nel termine sharing economy, chi in social innovation, chi in consumo collaborativo, qual è secondo lei il nome corretto?
Tanti nomi è vero. La bellezza di questo sta nel fatto che diverse persone hanno cominciato a riconoscere qualcosa, e anche un po’ indipendentemente uno dall’altro, l’ha definito in modo differente. Eviterei di usare la parola consumo, perché allude al concetto di “consumatore”, e a fronte di un sistema economico e culturale che ha ridotto le persone a consumatori, quello di cui stiamo parlando adesso può essere visto, invece, come l’inizio di una inversione di tendenza, in cui ancora piccoli gruppi, però significativi e in fase di espansione, organizzano servizi collaborativi – a noi piace chiamarli così- nei quali il ruolo del consumatore sfuma in quello di co-produttore. Questo naturalmente non significa che non consumeremo più, però è bello credere che sta succedendo qualcosa che contraddice stereotipi che sembravano fuori discussione.
Quale ruolo ha avuto la tecnologia in tutto questo e che ruolo pensa potrà continuare ad avere in futuro?
La tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale. Io non sono un tecnocratico e non penso che le cose siano determinate dalla tecnologia, ma che possano essere rese possibili da questa, sì. Quello a cui stiamo assistendo è il frutto di una combinazione molto articolata di fenomeni che non avrebbero potuto verificarsi se non fosse aumentato il grado di connettività delle persone. E siccome la società è fatta da persone che dialogano, le forme sociali sono date anche dai mezzi che si possono utilizzare in queste nostre conversazioni. Anche in passato quando sono cambiati i mezzi di comunicazione tra le persone, quando si è passato, per esempio, dalle culture non letterate a quelle che avevano capacità di scrivere, da quelle che usavano la mano per scrivere alla macchina, da quelle che comunicavano solo vis à vis a quelle con il telefono e la televisione, la società ogni volta ha subito profondi mutamenti.
Non è che il mezzo ha cambiato le cose in maniera meccanica, ma ha creato le condizioni perché cambiassero. Quello che sta succedendo ora in Cina e nei paesi del Medio Oriente mostra che la penetrazione di questi sistemi crea delle opportunità che prima non esistevano. Qualsiasi società ambientalmente e socialmente sostenibile sarà anche una società connessa e come tale avrà regole organizzative simili a quelle della rete. Quindi orizzontali, locali, e, in quanto connessa, anche aperte, potendo generare cose su una scala più elevata e quindi più importanti.
In una recente ricerca in Gran Bretagna è emerso che le persone desiderano “condividere” eppure lo fa ancora una piccolissima percentuale. Come si può coinvolgere più persone a consumare e a vivere in un modo più sostenibile?
Fino a ora protagonista di questo movimento è stata la middle class, che cerca in queste forme di organizzazione un nuovo modello di qualità della vita. Con la crisi, però, è possibile che lo scenario cambi. Da un lato, infatti, la middle class tende a diventare sempre più povera, dall’altro anche altri ceti possono scoprire che queste forme organizzative offrono delle opportunità. La Fondazione Housing Sociale della Cariplo, per esempio, sta facendo un lavoro egregio con il suo programma che prevede di costruire abitazioni ma nello stesso anche di formare comunità abitative, il che significa insegnare ai futuri coinquilini la gestione condivisa dell’edificio, del giardino, degli spazi per i bambini eccetera. Il car pooling può essere un’altra opportunità.
Il mix di crisi ambientale e economica rende sempre più difficile e costoso prendere la macchina e questo fa sì che le persone si organizzino per andare insieme in automobile con un evidente risparmio sui costi della benzina. Comprare direttamente dal contadino è un’esigenza nata da chi è particolarmente colto in termini alimentari, ma può anche diventare un modo per tutti per mangiare cose sane a un prezzo accettabile. Quindi pensando al futuro, una società che decidesse di usare le sue risorse in altro modo, potrebbe scoprire che alcune cose che sono state inventate da gruppi per motivi ideologici e politici possano essere riconosciute interessanti anche per altri.
Uno dei pensieri su cui si forma questo movimento è che noi possediamo già tutte le risorse per soddisfare i nostri bisogni. Lei stesso sostiene che il fatto che siamo 7 miliardi non deve essere trattato come un problema ma come un’opportunità. Come facciamo a coordinarci in modo da tirar fuori il meglio di noi e non il peggio?
Ovviamente non c’è una formula magica: le piattaforme offrono delle opportunità. Le regole mettono dei limiti. Il resto, per fortuna direi, è aperto. Però la qualità del progetto può rendere certi comportamenti virtuosi (cioè che si giudicano come positivi) più probabili: per esempio una piattaforma che mette in contatto diretto un gruppo di cittadini con un una o più fattorie che producono cibo biologico, non può impedire che queste ultime possano truffare i primi proponendo come biologico qualcosa che non lo è. Ma il modo in cui è impostata la piattaforma può rendere più visibili, e quindi controllabili, i processi (e quindi anche promuovere un controllo diretto sulla natura dei prodotti).
Inoltre, in parallelo con questo, il progetto può essere tale da proporre un set di qualità capaci di aiutare l’emergere ed il diffondersi di questi comportamenti virtuosi. Per restare nel campo dell’agricoltura e del cibo, e fare un esempio ben noto, si può citare il caso di Slow Food. Quest’associazione infatti, non solo ha proposto con successo “piattaforme” operative capaci di incidere nell’organizzazione dei rapporti tra contadini e cittadini (dagli iniziali Presidi agli attuali mercati dei contadini a Terra madre), ma promosso anche un’idea di qualità alimentare (e quindi di qualità della vita) che è stata capace di riorientare le idee su cibo e agricoltura di un gran numero di persone in tutto il mondo.
Quale ruolo possono svolgere i designer nella progettazione di servizi collaborativi?
Va premesso che tutti i servizi collaborativi sono progettati da qualcuno, sono cioè, di fatto, il risultato di un processo di co-progettazione in cui sono stati coinvolti diversi attori, inclusi quelli che tradizionalmente sarebbero stati gli utenti finali del servizio stesso. Data questa premessa, si può dire che, in questi casi, il ruolo del design (inteso ora come l’attività di professionisti del progetto) è quello di stimolare, alimentare e supportare questa più ampia e articolata attività di co-progettazione. In breve: un designer (cioè un professionista del progetto) ha il ruolo di aiutare gli altri attori sociali, non professionisti del progetto, a progettare. Questo ruolo del design può essere messo in atto con modalità e a livelli diversi.
Se immaginiamo i processi di co-progettazione come una conversazione strategica tra diversi partner, il designer può contribuire a stimolarla ed alimentarla producendo conoscenze orientate al progetto (immagini chiare e comunicative dei problemi e delle risorse disponibili), costruendo scenari (visioni motiviate di mondi possibili e auspicabili), realizzando prototipi (artefatti realizzati allo scopo di verificare in concreto le implicazioni delle idee proposte). Può infine usare la sua esperienza e sensibilità per introdurre e diffondere nuove idee di qualità.
E questo, come dicevo, può avvenire a diversi livelli: collaborando con un gruppo locale, con una comunità di quartiere, con una città. Ma anche alimentando la conversazione strategica alla scala più vasta, producendo visioni e scenari su come potrebbero essere una società ed un sistema produttivo sostenibili. Con riferimento al tema che qui abbiamo discusso, come potrebbero essere una società ed un sistema produttivo basati sulle idee di cittadinanza attiva e collaborativa e di sistemi (progettuali, produttivi e di consumo) distribuiti nelle reti sociali.
Abbiamo il designer che facilita e stimola, la cittadinanza che partecipa… A questo punto per creare servizi collaborativi che funzionino ci vogliono, immagino, le amministrazioni locali, un attore che mi sembra fondamentale. Sbaglio?
No non sbaglia affatto, anzi. Con la rete Desis stiamo sviluppando dei cluster tematici che si svolgono in diversi laboratori sparsi tra l’Europa e l’America. Il primo cluster, che farà da pilota, si chiama proprio Pubblic and Collaborative e ha l’obiettivo di capire come potrebbe cambiare il servizio pubblico se invece di offrire un servizio a un individuo passivo, fornisse delle piattaforme per incentivare, abilitare e supportare i cittadini ad avere comportamenti attivi e collaborativi. È evidente, infatti, che per il gestore dei servizi la condivisione dei servizi è un’opportunità straordinaria. Il car polling, per esempio, può significare strade più libere ma anche riduzione dei costi per le amministrazioni se i cittadini si organizzano ad andare in macchina insieme. Così i Circle of care sono circoli di cura in cui le persone che hanno gli stessi problemi invece di dipendere tutti dal centro medico possono mettersi in contatto e aiutarsi tra loro e lasciare che il centro medico intervenga solamente nei momenti necessari.
Questa non solo è un’idea bellissima ma porta anche un servizio migliore, perché nessun servizio centralizzato avrà mai il tempo di dedicarsi a ogni singolo paziente offrendogli il tempo e l’attenzione che possono invece essere rivolti da un’altra persona che si trovi, o si sia trovata, ad affrontare esperienze analoghe. Certo, l’organizzazione collaborativa dei servizi non deve essere vista come un modo per tagliare le spese perché altrimenti non funziona. Il servizio pubblico deve continuare a essere presente, ma in maniera diversa. Noi che stiamo studiando da un po’ queste organizzazioni abbiamo visto che i casi di successo sul lungo periodo sono quelli in cui c’è una specie di circolo virtuoso tra ciò che viene dal basso, gli inventori sociali diffusi nella società, che ci mettono anche il loro entusiasmo e le loro energie, e un intervento che viene dall’alto (cioè messo in atto da qualche ente pubblico o privato che supporta l’iniziativa con regole, esperti, materiali, e spazi). Così si spende più o meno lo stesso ma si arriva a un servizio personalizzato, più presente e vicino alle esigenze degli utenti. Se invece si usano queste forme di collaborazione soltanto per tagliare le spese, come per esempio era stato proposto in Inghilterra con il programma The Big Society di Cameron, queste iniziative non funzionano e non durano a lungo.
A che punto siamo in Italia?
L’Italia è un paese strano c’è il meglio e il peggio di tutto quanto. In Italia ci sono molte cose egregie ma un po’ isolate fra loro. Il successo che hanno avuto internazionalmente le nuove idee sul ciclo alimentare si devono in grande parte a Slow Food, il movimento dei gruppi di acquisto da noi ha una dimensione maggiore che da altre parti, i mercati dei contadini sono più belli e più ricche in Italia che in altre nazioni. Certo la Gran Bretagna è la Hollywood di questo movimento, perché Cameron, in maniera distorta, e il Labour, in maniera meno evidente ma più corretta, hanno sovvenzionato Fondazioni e centri di ricerca. L’Italia se la si guarda in generale non fa una bella figura, ma se ci si pulisce un po’ gli occhiali e si guarda bene, si possono trovare situazioni molto interessanti, anche più stimolanti e vivaci che altrove.