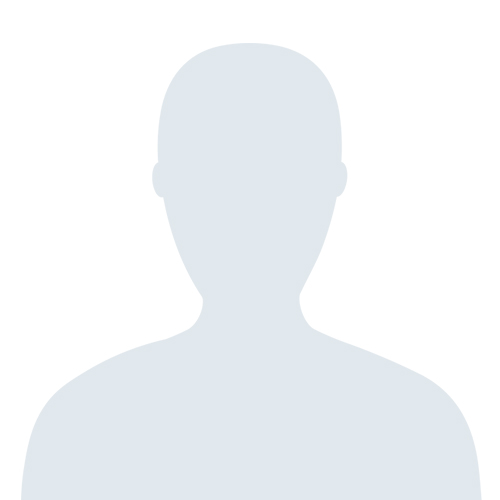Prosegue la strategia anti-pirateria delle grandi società d’intrattenimento USA. Strategia che stavolta mira a colpire i campus universitari ed i relativi network ad alta velocità, presunti colpevoli di “online piracy.” Questo il senso di una missiva inviata ad oltre 2.000 rettori universitari dalla Recording
Industry Association of America (RIAA), dalla Motion Picture Association of America (MPAA) ed altri consorzi industriali. Secondo costoro un ampio numero di studenti continuerebbe ad approfittare delle risorse offerte dai vari istituti onde violare le leggi federale sul copyright. Uno dei passaggi centrali della lettera sostiene tra l’altro che “vanno intrapresi tutti gli sforzi, estesi e continuati, per tenere sotto controllo un simile livello di pirateria.” La manovra non è altro che l’ultima di una serie di iniziative tese a stroncare ogni minimo ritorno al file-sharing generalizzato, fenomeno che a fine 1999 portò all’esplosione di Napster e suoi derivati innanzitutto all’interno del campus universitari.
In questo caso la nota non arriva a minacciare alcuna azione legale, come invece accaduto nella recente denuncia (tuttora irrisolta) avviata dalla stessa RIAA contro il provider Verizon Communications per ottenere i dati personali di un utente presumibilmente dedito al file-sharing illegale. Non mancano però le forti pressioni contro gli organi universitari per l’implementazione di procedure capaci di prevenire possibili infrazioni, monitorando i comportamenti dei singoli e imponendo “efficaci rimedi” contro quanti vengano colti con le mani nel sacco. Insomma, la solita policy di “zero-tolerance” tanto cara agli studios di Hollywood. Una policy già espressa da analoghe iniziative in quest’ambito, incluse le segnalazioni della MPAA riguardo specifici casi di “reato” nei campus e annessi inviti a desistere. Queste pratiche sembrano tuttavia provocare repliche alquanto diversificate da parte degli amministratori universitari. Mentre alcuni sono ricorsi a restrizioni di tipo tecnico, imponendo drastiche riduzioni all’ampiezza di banda disponibile nei dormitori, altri hanno deciso di rispettare la tradizione di lasciare massima libertà agli studenti (è il caso del MIT). Resta tutto da vedere se e quali risultati produrranno queste ennesime pressioni pro-copyright.
Un ambito quest’ultimo che rimane sempre caldo, come testimoniano le audizioni in svolgimento in questi giorni presso la Corte Suprema sulla costituzionalità (o meno) della recente estensione del copyright di ulteriori 20 anni approvata mesi fa dal Congresso USA. Una prassi comunemente seguita dai parlamentari onde evitare che i pilastri dell’industria dell’entertainment, vedi Micky Mouse (Topolino), possano divenire di pubblico dominio. Oggi il copyright su opere realizzate da società riceve una tutela pari a 95 anni, mentre per i singoli vale fino alla morte e per i 70 anni successivi. A parte i grossi nomi (che equivalgono a grossi profitti) generalmente tale tutela non viene rispettata al millimetro, e spesso il passaggio nel pubblico dominio avviene ancor prima e senza clamori. Sostanzialmente ciò è dovuto al fatto che non esiste un apparato centrale addetto alla verifica di tale passaggio, contrariamente, ad esempio, al Patent and Trademark Office che monitora assai attentamente il limite dei 20 anni assegnato ai brevetti. A ben vedere, un utilizzo elastico del pubblico dominio è storicamente quello che ha consentito ai vari autori di prendere in prestito e rivisitare le opere già prodotte. Un caso esemplare sono i testi teatrali di Shakespeare, per lo più rifacimenti di pezzi altrui e di ambito popolare assemblati magistralmente. In tal senso, copyright e pubblico dominio s’intersecano a creare quello che rimane obiettivo importante per la trama sociale: creare un ambito in cui, pur tutelando le opere degli autori originari, venga stimolata la creatività delle nuove generazioni e la libera circolazione delle idee (come sostiene da sempre Richard Stallman, qualcuno che di copyright se ne intende).
In tal senso, va segnalato il lavoro di due entità — Internet Archive e Creative Commons — mirate alla rimozione delle barriere burocratiche nella ricerca dei materiali di effettivo dominio pubblico. La seconda, organizzazione nonprofit, punta in particolare al “riutilizzo creativo di ogni tipo di opera intellettuale”, e sta elaborando delle licenze di copyright che consentano agli autori di diffondere in pubblico i rispettivi lavori con maggiore rapidità rispetto alle attuali leggi, pur mantenendo alcuni diritti specifici. Nelle parole di Glen Otis Brown, executive director di Creative Commons, “stiamo cercando di creare licenze che possano promuovere certe libertà, imponendo però alcuni limiti nel rifacimento dei lavori, quali il mantenimento dei ‘credit’ per l’autore originale o il divieto di ottenerne guadagni commerciali senza il suo permesso.” (Anche qui traspare l’influenza di quella geniale trovata che rimane la GPL, ideata dallo stesso Stallman).
Un ultima segnalazione in questo contesto necessariamente ampliato del copyright nell’era digitale — anziché restrittivo come propugna anacronisticamente Hollywood — arriva ancora dal Massachusetts Institute of Technology di Boston. Il quale ha appena deciso di pubblicare liberamente online i materiali di tutti i corsi di laurea — per un valore complessivo superiore ai 100.000 dollari, secondo calcoli basati sulle rette imposte agli studenti in loco. Il progetto prevede la diffusione integrale di tali materiali (relativi ai circa 2.000 corsi offerti a tutt’oggi) entro l’anno scolastico 2006-2007. Un’iniziativa tesa a fornire un approccio univoco alle classi online del MIT ma soprattutto ad unificare due fenomeni emergenti: la didattica a distanza e il software open source su cui questa si basa. “La nostra battaglia è contro la commercializzazione della conoscenza, analoga a quella del mondo open source contro la commercializzazione del software,” spiega Jon Paul Potts, portavoce del MIT. Replicando il modello di quell’ambito, l’istituto ha infatti posto delle restrizioni all’utilizzo dei propri materiali online, tipo il divieto alla creazione di derivati a scopo commerciale. E pur se gli studenti sembrano studiare avidamente nel virtuale, ciò non va inteso a sostituzione dell’insegnamento reale in aula né il MIT offre alcun diploma via Internet. Si tratta, piuttosto, di un nuovo passo avanti verso i “sistemi di conoscenza aperta,” secondo un’affermazione dello stesso presidente del MIT Charles Vest. Il futuro accademico va cioè spostandosi lungo nuove strade per l’insegnamento e l’apprendimento, strade ‘open’ anziché ‘closed’ — facendo tesoro della lezione imposta nell’ambito informatico dai movimenti di opposizione al sistemi proprietari (in particolare quello del software libero, concepito proprio al MIT grazie soprattutto al solito Stallman).