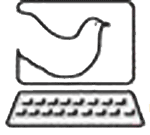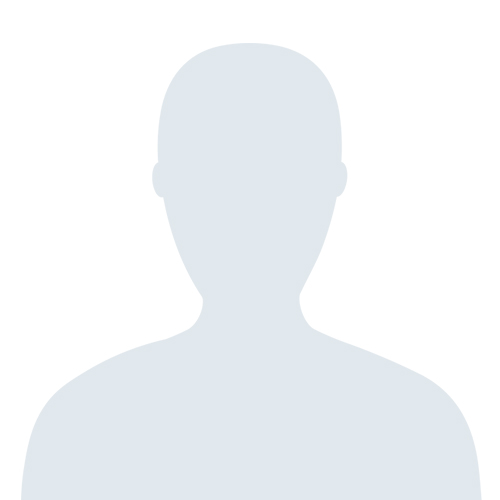“Incriminato – accusato – processato – perquisito”: queste parole sono state trasmesse su tutti i teleschermi d’America durante l’ultima edizione del Superbowl. Ma non si trattava di uno spot della CIA per festeggiare l’arresto di qualche terrorista. La finale del campionato di football, tra i maggiori eventi mediatici degli Stati Uniti, si è trasformata in un “palcoscenico” per la Pepsi Cola e la RIAA (Recording Industry Association of America), la lobby dei discografici statunitensi, che hanno deciso di associare ad azioni criminose il volto di ragazzini adolescenti già accusati dalle autorità locali per aver scambiato musica in rete. Un messaggio pubblicitario assai chiaro: se condividi musica sei un criminale, ma se bevi la Pepsi puoi farlo legalmente e redimerti agli occhi del mondo.
Dieci anni fa il “crimine telematico” per eccellenza non era lo scambio di musica (la compressione MP3 era ancora un lontano miraggio), ma addirittura la “detenzione di modem”. A che serve un modem – si chiedevano giornalisti e magistrati – se uno non ha loschi traffici da gestire, guerre termonucleari da scatenare o messaggi segreti da scambiare? Nel maggio 1994 la terribile equazione che associava la comunicazione elettronica alle attività illegali si è trasformata da “semplice” deficit culturale in un vero e proprio teorema giudiziario, che ha scatenato l’ira funesta della Guardia di Finanza su centinaia di persone “colpevoli” di aver gestito dei Bulletin Board System (BBS), una di quelle “bacheche elettroniche” caserecce che oggi sembrano preistoria informatica.
Prima di essere “sorpassate” dal boom di Internet, nato in Italia con le speculazioni di Video On Line, quelle bacheche elettroniche gestite da privati, e basate su regole ferree che non consentivano il transito di messaggi pubblicitari, sono state la palestra sulla quale si è formata una generazione di “utenti telematici consapevoli”, che ancora oggi cercano di resistere allo “zapping telematico” orchestrato in rete dai giganti delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento.
Nel 1992 una pesantissima azione di lobby della BSA (Business Software Alliance), la “santa alleanza” dei produttori di software, era riuscita a far approvare delle modifiche alla legge sul diritto d’autore che introducevano una distinzione tra i programmi informatici e le altre opere dell’ingegno, sanzionando col carcere la copia di software “a scopo di lucro”.
È dall’applicazione distorta di questa “legge su misura” che due anni più tardi nasce l’operazione “Hardware 1”, passata alla storia con il nome di “Italian Crackdown”: dalla procura di Pesaro partono 173 decreti di perquisizione, che attivano 63 reparti della Guardia di Finanza per una serie di sequestri a tappeto: vengono sequestrati 111.041 floppy disk, 160 computer, 83 modem, 92 CD, 298 streamer e 198 cartridge. Ma non solo. Si confiscano anche dei “reperti” totalmente inutili alle indagini: documenti personali, riviste, appunti, prese elettriche, monitor, stampanti, tappetini per il mouse, contenitori di plastica per dischetti, kit elettronici della scuola radio elettra scambiati per apparecchiature di spionaggio. Si arriva a ‘sequestrare’ perfino un’intera stanza del computer, sigillata dalla Finanza nel timore che da quella stanzetta qualcuno potesse innescare la terza guerra mondiale.
Molti dei denunciati scelgono di patteggiare, pur consapevoli di non aver fatto nulla di illecito. Altri ne fanno una questione di principio e vanno fino in fondo, come Giovanni Pugliese, fondatore dell’Associazione PeaceLink, che viene pienamente scagionato nel 2000 dopo un calvario giudiziario durato sei anni.
Dopo quell’episodio l’azione di lobby realizzata dalla BSA (e da Microsoft che la finanzia) si è fatta più sottile e impercettibile, ma certo non meno devastante. Il 26 novembre 1996 la pretura circondariale di Cagliari dichiara in una storica sentenza che copiare software non sempre è reato. La parte in causa è una ditta privata che installa lo stesso programma su tre computer differenti. Il giudice spiega che il fatto non costituisce reato perché “c’è una differenza tra lucro e profitto,” e la legge punisce solo la copia fatta per lucro, per guadagnare dei soldi, e non quella fatta con profitto, risparmiando sul mancato acquisto di un software. A questo punto, con la legge 248/2000, un nuovo “ritocco” alla legge 633/41 sul diritto d’autore sostituisce magicamente le parole “a scopo di lucro” con “per trarre profitto”, e dalla sede centrale di BSA partono immediatamente i fax intimidatori con cui si avvertono le aziende del nuovo cambio di regole.
Questa ennesima “blindatura” del diritto d’autore sul software riesce a introdurre per la copia di software pene simili a quelle per omicidio colposo, e chi copia un programma per uso personale viene trattato allo stesso modo di chi ne fa migliaia di copie per rivenderle sul “mercato nero” dell’informatica. Ma c’è ancora un buco: per quanto riguarda la copia di musica e di video, la legge 248/2000 introduce una distinzione, e punisce la copia di film e canzoni solo se viene effettuata “per uso non personale” e “a scopo di lucro”.
L’opera di criminalizzazione di qualsiasi copia di opere dell’ingegno viene completata dall’Unione Europea, che nel 2001 ha emanato la Eucd, la direttiva europea sul Copyright recepita In Italia con il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 (che pure lascia una residua possibilità di ‘scambio culturale’ tra gli utenti). E l’ultimo pastrocchio legislativo e’ arrivato con il famigerato “Decreto Urbani”, che cambia poco nella sostanza giuridica, ma ha seminato già il panico nel grande pubblico della rete.
Una convergenza repressiva globale che trova spiegazione, tra gli altri, nell’opera e nel pensiero di John Perry Barlow, tra i fondatori della “Electronic Frontier Foundation”, uno dei molti sostenitori del diritto allo scambio libero e gratuito di opere dell’ingegno, una pratica che affonda le sue radici nella storia dell’umanità e che oggi qualcuno vorrebbe etichettare come “pirateria”. Rileggiamo parte della sua “Dichiarazione di indipendenza del Cyberspazio”, scritta nel 1996 ma attualissima ancora oggi:
“Le vostre strutture dell’informazione, sempre più obsolete, tenteranno di perpetuarsi proponendo nuove leggi, in America e in tutto il mondo, per affermare di possedere la parola stessa. Queste leggi definiranno le idee come un altro prodotto industriale, non più nobili del volgare ferro. Nel nostro mondo, qualunque cosa creata dalla mente umana può essere riprodotta e distribuita all’infinito senza alcun costo. La trasmissione globale del pensiero non richiede più l’appoggio delle vostre fabbriche. Queste misure ostili e coloniali ci pongono nella medesima posizione di quegli amanti della libertà e dell’autodeterminazione che in altri tempi sono stati costretti a non riconoscere l’autorità di poteri distanti e disinformati. Abbiamo il dovere di dichiarare le nostre identità virtuali immuni al vostro potere, anche se dovessimo continuare a rispettare le vostre leggi con i nostri corpi. Ci sparpaglieremo su tutto il Pianeta in modo che nessuno possa arrestare il nostro pensiero. Noi creeremo la civiltà della Mente nel Cyberspazio. Che possa essere più umana e giusta del mondo fatto dai nostri governi”.
In questo contesto complessivo, fare memoria dell’Italian Crackdown non è perciò un atto nostalgico da reduci dell’epoca d’oro delle BBS, quanto piuttosto passaggio necessario per interrogarsi sui benefici e gli svantaggi dei due approcci culturali e filosofici che oggi guidano lo sviluppo tecnologico, culturale e commerciale: il modello “proprietario” e il modello “libero”. Due modelli di sviluppo e di ricerca caratterizzati da un approccio diametralmente opposto a questioni delicate e cruciali come la proprietà intellettuale, il copyright e i diritti di sfruttamento economico delle invenzioni.
In tal senso, il libro che ho scritto su quei tristi eventi Italian Crackdown, è stato primo volume italiano diffuso con una licenza “open content”, che ne ha permesso la pubblicazione in rete sin dal primo giorno di presenza in libreria. Anzi, la mia passione per la telematica sociale di base è nata proprio in quel 1994, scoprendo con orrore che qualcuno aveva pagato con una persecuzione giudiziaria la creazione delle prime comunità virtuali italiane. Da allora, anche grazie alle esperienze di “cittadinanza attiva” del cyberspazio realizzate all’interno dell’associazione PeaceLink, non ho più smesso di interessarmi ai problemi della comunicazione e delle nuove tecnologie dell’informazione. Oggi riesco a vivere di quello che scrivo, e non ho bisogno di mandare in galera i ragazzini che scaricano le mie opere attraverso i circuiti peer-to-peer. In questo preciso momento il mio client “emule” segnala la presenza di 18 utenti che hanno nel loro computer uno dei miei libri, e questo mi riempie di gioia, mentre qualcun altro al mio posto vorrebbe chiamare il 113.
Spero che in futuro ci sarà un numero sempre maggiore di autori che decideranno di aprire i loro cassetti per far parte dell’intelligenza collettiva della rete, dove quello che si riceve è infinitamente maggiore di quello che si potrà mai donare in tutta una vita.