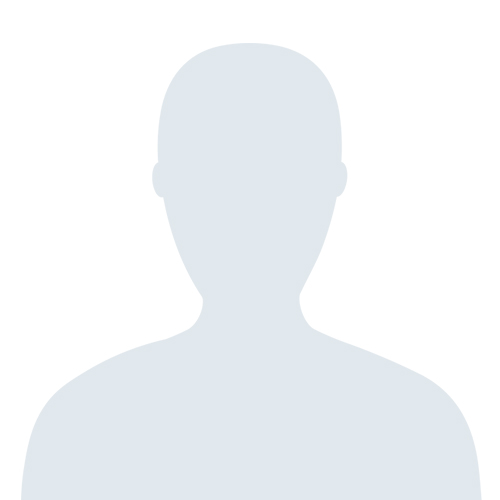È una primavera di produzione distribuita dell’informazione per il giornalismo italiano, questa. Da Dig-it a Youcapital, fino all’ultima proposta, Spot.us Italia, versione nostrana del modello americano nato due anni fa cui si ispirano un po’ tutti questi siti. La proposta è quella di ristabilire una relazione fra la richiesta di informazione su tematiche specifiche da parte dei cittadini e la produzione di contenuti professionali da parte di giornalisti, consentendo un approfondimento tipico del giornalismo d’inchiesta. Questo obiettivo si realizza attraverso una forma di crowdfunding trasparente che consenta la costruzione collettiva e distribuita dell’informazione, con un equilibrio fra Creative Commons sui pezzi pubblicati e vendita dei diritti a testate che vogliono pubblicare in anteprima. E senza dimenticare come, in un periodo di crisi editoriale e professionale, questo – come ricorda la componente sindacale dei freelance – rappresenta un modo di aprire un canale alternativo per coloro che sono «sfruttati e sottopagati, offrendo loro un’opportunità di lavoro alternativa, tutelato sia dal punto di vista etico che economico, con compensi professionali che molti editori non garantiscono» (interessanti in tal senso i due articoli scritti da giovani giornalisti in formazione a Urbino).
Cogliere il cambiamento
La sfida è interessante, soprattutto pensando di poter constatare sul medio periodo risposte sui due lati: lettori (proponenti e finanziatori) e giornalisti e sui temi proposti, raffrontandole culturalmente con l’esperienza americana. Prendiamo Spot.us Italia, un buon metro culturale di confronto, perché brand di derivazione diretta dal progetto del giornalista freelance David Cohn, già raccontato a suo tempo su questa parte della Rete per prima da Antonella Napolitano. Non è un caso che proprio Antonella Napolitano sia coinvolta nello sviluppo del progetto italiano, assieme a Antonio Badalamenti, giovane economista e project manager, e Federico Bo, ingegnere informatico che riflette sulla forma che il web in chiave sociale assume e sviluppa progetti. Un bel connubio tra informare e fare, a cui le pratiche social della Rete ci stanno abituando.
Non è solo l’ennesimo esempio su “come fare giornalismo partecipativo”. Possiamo guardarlo anche da altre prospettive. Prospettive che hanno a che fare con la natura culturale e politica del giornalismo italiano e del pubblico mediale. Ma anche con la forma che l’inchiesta giornalistica assume oggi. Per cominciare: quali giornalisti e quali cittadini italiani ci aspettiamo partecipino? Federico Bo mi racconta che si pensa a «giornalisti in grado di cogliere il cambiamento in atto nel loro settore, a loro agio con le nuove tecnologie e con le nuove filosofie della Rete, attenti al territorio dove vivono e lavorano, ansiosi di poter produrre e pubblicare contenuti di qualità, in grado di esplorare la realtà oltre la superficie». Mi vengono in mente i molti giornalisti insoddisfatti che si stanno aprendo blog o cercano altri luoghi nei quali affrontare il racconto quotidiano della realtà a fronte di redazioni che necessitano sempre più di contenuti taglia e cuci di stampo news.
Cittadini attivi
Poi ci sono i «cittadini che hanno scoperto il potere aggregativo e partecipativo della Rete, stufi di vedere una rappresentazione distorta e addomesticata della realtà imposta loro dalla quasi totalità dei media mainstream. Cittadini e lettori attivi, responsabili, attenti, in grado di rivelare storie, vicende, fatti e misfatti che avvengono vicino a loro, nel loro quotidiano. Lettori attivi, che non solo vogliono finanziare le inchieste, ma vogliono contribuire con il loro impegno, collaborando con il reporter che effettua l’inchiesta». Ma anche «tutte le associazioni, i comitati o i gruppi che si auto-organizzano online per sostenere una causa o denunciare una situazione». Un mix efficace fra una fame di informazione non solo da leggere, ma da generare a partire dalle storie quotidiane che ci circondano e la capacità di fare lobby per mettere nell’agenda dei media un tema che spesso non entra.
Così vorrebbe la logica della cittadinanza aperta alle prospettive di connessione del digitale. In realtà, esplorando i luoghi conversazionali come FriendFeed o Twitter, o la pagina Facebook del progetto, troviamo – per ora – una tiepida accoglienza da parte degli abitanti italiani della Rete. Le cose si costruiscono con calma in questo settore, ma mi sembra di poter dire che ancora una volta la Rete, nella nostra versione locale, non si mostra così innovativa nell’aprirsi a una responsabilità civica, alle forme di partecipazione non auto-riferite – parlare di sé, auto incensarsi eccetera. La dimensione centrale di questo progetto resta però la natura d’inchiesta in rapporto all’informazione nel nostro paese: «non è un caso – racconta Federico – che la nostra, come altre iniziative simili, stiano nascendo in Italia prima che in altri paesi europei. La “fame” di giornalismo d’inchiesta è alta ovunque ma in Italia questa domanda, sotterranea ma palpabile, è prioritaria (vedi il successo di trasmissioni “di resistenza” come Report). Dico, riprendiamo e riprendiamoci il racconto della realtà, la realtà che vive oltre la superficie, al di là degli slogan, dietro l’(auto)-illusione».
Dubbio e sospetto
E qui troviamo un punto delicato nell’ottica del giornalismo investigativo che ha a che fare con la distinzione tra cultura del dubbio e quella del sospetto, come racconta Mario Tedeschini Lalli, che si occupa non solo di fare giornalismo ma di formare al giornalismo, con grande attenzione per la trasformazione in atto. Se pensiamo all’Italia di oggi sembra che i prodotti medialmente più premiati ed interessanti in questo senso, quelli su cui convergono larghi strati di pubblico e l’interesse delle nuove generazioni di giornalisti, abbiano a che fare con la dimensione narrativa alla Gomorra di Roberto Saviano o con la scrittura indignata e, in qualche modo, militante alla Marco Travaglio. Spiega Tedeschini Lalli:
Un vecchio maestro di giornalismo come Silvano Rizza, usava dire ai suoi praticanti nelle redazioni e nelle scuole che ha guidato: “Il giornalista deve vivere la cultura del dubbio, non la cultura del sospetto”, mentre sempre più spesso i giornali vivono e utilizzano la cultura del sospetto. E’ una cultura dietrologica, basata su nessi solo ipotizzati o supposti come probabili, una narrazione del “non poteva non sapere”, esclusione di dati contradditori, sillogismi. Il giornalista giustamente “dubbioso” raccoglie dati per accertare la consistenza reale del dubbio che gli è venuto, poi li mette in correlazione con altri fenomeni, infine cercare di stabilire un rapporto di causa-effetto. Sono le tre attività più importanti nel giornalismo investigativo e – direi – nel giornalismo in genere e non possono essere confuse.
Mi chiedo allora: sarà la pratica del dubbio o quella del sospetto a stimolare il desiderio di inchiesta nei cittadini? E quali giornalisti parteciperanno, quelli che praticano il dubbio o il sospetto? Non c’è sospetto dietro queste mie domande, solo dubbi. Dubbi che derivano dalla relazione particolare che in Italia si ha tra la forma narrativa che assumono molti contenuti mediali di stampo informativo e il bisogno di un racconto sociale “dal basso” che cerca di farsi spazio perché non si sente, spesso, rappresentato nei media.