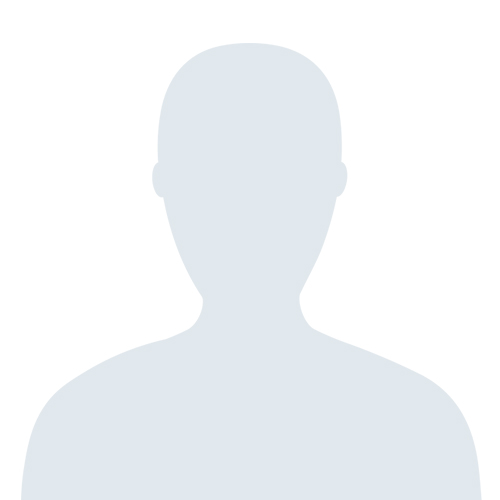Giusto un annetto fa la prestigiosa agenzia di stampa Associated Press titolava: Divorziata on line arrestata per l’omicidio del marito virtuale. Detta così la notizia potrà far rabbrividire più d’uno tra i migliaia di videogiocatori, e genitori di avatar sui social network che ogni giorno fanno strage di amici nelle arene di Tekken, World of Warcraft o ci litigano nel più mite PetSociey. La storia riportata da AP è quella di una quarantenne giapponese il cui personaggio su Maple Story, un MMORPG con più di 100 milioni di giocatori, si era visto scaricare senza preavviso dal marito virtuale. La donna, per vendicarsi del brutale divorzio, ha pensato bene di uccidere il marito. O meglio l’avatar-marito.
Ciò che il titolo sensazionale non dice, infatti, è che la donna è stata arrestata per aver violato il computer dell’uomo che gestiva il personaggio fedifrago. Niente omicidio dunque, solo un furto di identità degno di un hacker di provincia. Ciò che colpisce è il fatto che nel titolo di AP è la morte a essere protagonista. Un tipo di morte inconsistente, raccontata, virtuale che circonda la nostra esistenza quotidiana.
Stragi del sabato pomeriggio
Quello che chiamiamo un tranquillo sabato pomeriggio farebbe rabbrividire chiunque avesse avuto la sfortuna di vivere durante la Guerra del Trent’anni, uno dei conflitti più sanguinosi della storia d’Europa. Si comincia con il dopopranzo: una sbirciata al giornale ci racconta la morte di sedici persone. Giorno fortunato perché Iraq e Afghanistan se ne sono stati tranquilli. Una passeggiata in centro e si incrocia una mostra fotografica sulla repressione in Tibet e in Birmania. A casa Twitter racconta della violenza in Iran. I giornali online discutono l’opportunità di mostrare le foto del caso Cucchi o dell’esecuzione dei Quartieri Spagnoli. Intanto gli si dà un’altra occhiata. E poi, dalla prima serata fino a notte fonda, ci si sciorina una lunga teoria di cadaveri a partire dalla giustizia sommaria di Chuck Norris, fino agli 865 morti accertati dell’episodio il Ritorno dei Re della saga del Signore degli Anelli di Peter Jackson; i cadaveri sezionati di CSI e Dexter e giù giù fino alle livide riprese di un Giorno in Pretura. Circondati di cadaveri inconsistenti il cui sangue non sporca, non macchia, non ha odore ci godiamo la morte come spettacolo da raccontare. E attraverso gli avatar la possiamo persino provare.
Morire per finta
La vita virtuale assomiglia sempre di più alla vita reale. Il New York Times riporta che quest’anno il giro d’affari dei cosiddetti beni virtuali sia di almeno 5 miliardi di dollari. Una economia che comprende l’acquisto di denaro su Pet Society o un costume di Halloween su Sorority Life, giochi di ruolo che ospitano milioni di vite immaginate. Non è più solo un gioco: quando le persone cominciano a investire giorno per giorno in piccoli e grandi miglioramenti della condizione del proprio rappresentante è il segno tangibile di un coinvolgimento emotivo. E dunque la fine non potrà che assomigliare sempre di più a una morte vera. Digitale o biologica che sia fa comunque paura. C’è bisogno di elaborare. E soprattutto c’è bisogno di capire come si muore.
Il pericolo più angosciante è la fine del mondo. L’apocalisse da queste parti è provocata da un management sbagliato, dal rapido decadimento del modello di gioco o dall’arrivo di un nuovo gioco o una nuova piattaforma che risucchia via gli utenti fino all’implosione della struttura. E una mattina ci si ritrova con la parola magica che invece di dare l’accesso ad una vita alternativa, ci restituisce un paio di righe di commiato da parte dell’azienda che ne gestiva la piattaforma. Come è successo ad Asheron’s Call 2 (che vide scendere la sua popolazione dai 50.000 ai 10.000 membri), Shadowbane (che una petizione dei suoi giocatori salvò dalla fine per oltre un mese) entrambi catalogati come defunct nella lista dei MMPORG di Wikipedia. Può anche capitare che l’apocalisse si sia limitato al solo nostro rappresentante virtuale, ucciso o meglio “bannato” per qualche violazione. E allora comincia la penosa odissea kafkiana degli help center, gli appelli accorati per la restituzione alla vita da parte di fiancheggiatori e amici. Molti rinunciano e preferiscono ricominciare.
Gesti estremi
E poi ci sono i suicidi. Qualche tempo fa il TimesOnline raccolse le storie di alcuni “suicidi” di Facebook. Erano ancora tempi non sospetti, lontani dai rumors sulla sofferenza del social network ai quali stiamo assistendo in questi giorni. Per nessuno era stata una scelta facile. Avevano investito nel loro profilo tempo ed energia emotiva. Avevano avuto bisogno di una motivazione forte per compiere il gesto estremo. Motivazioni che sono ancora valide per gli aspiranti suicidi attuali. E così si scopre che c’è chi lo fa perché l’estrema esposizione (soprattutto agli ex partner non rassegnati) mette in pericolo la vita sentimentale reale e con un messaggio pieno di tristezza passa a miglior vita, quella reale. C’è invece che lo fa per riconquistare la preziosa protezione della privacy e c’è chi, avendo costruito una vetrina di sé ha potuto toccare con mano la banalità della propria esistenza e l’ha trovata insopportabile. C’è anche chi ha dovuto rinunciare per “forza maggiore”, per le numerose azioni di contrasto che alcune aziende e organizzazioni hanno posto in essere contro l’esposizione e il tempo perso sulla propria bacheca personale. Ma per tutti il problema maggiore è che ciò che è troppo personale rende vulnerabili. Il suicidio però, rimane una soluzione drastica. Letteralmente dolorosa.
Seppukkoo è solo una provocazione. Seppukoo è un servizio 2.0 che accompagna la morte del proprio account Facebook, ed è ispirato al seppukku, il suicidio rituale giapponese. Alla semplicissima (e troppo razionale) cessazione dell’account, Seppukoo ricostruisce l’intera sovrastruttura rituale del lutto: aiuta a costruire un monumento funebre e ad avvertire gli amici della dipartita (con un invito virale a seguire l’esempio). Ma Seppukkoo è solo una provocazione perché la morte sarà solo apparente: basterà loggarsi nuovamente in Facebook e tutto sarà tornato come prima.
Finché non succede il disastro, finché non si presentino motivazioni forti, le personalità on line fanno fatica a morire. Si lasciano agonizzare inutilizzate, il polso appena percettibile ma tuttavia presente e vivo. Quasi nessuno si prende la briga di “uccidere” il proprio avatar. Le liste di amici sono popolate di profili mezzo abbandonati, mai completati, la cui attività si limita a qualche flebile lamento. Indistinguibili dai morti veri. Alcuni social network si stanno ponendo il problema degli user abbandonati causa della morte biologica del proprietario. Continuano a dare segni di vita a causa delle interazioni automatizzate ma dietro non c’è più nessuno. Per i parenti non è facile accedere mettere fine a quella estensione vitale. E così continuano a riceve inviti, richieste di amicizia, poke. Senza sapere che si sta toccando un cadavere.
Una parte di noi
Sebbene sia facile morire e rinascere da queste parti è comunque una scelta difficile. Quei piccoli agglomerati di pixel, esseri simbolici nei quali ci si riconosce, sono comunque un pezzo di noi stessi. Li abbiamo curati, protetti, cresciuti, gli abbiamo regalato funzionalità e gadget. Li abbiamo chiamati per nome. Un coinvolgimento emotivo sottolineato dai ricercatori Byron Reeves e Clifford Nass della Stanford University in un testo del 1996, The Media Equation, secondo il quale le persone reagiscono ai media, computer compreso, come fossero reali:
Le risposte delle persone mostrano che i media non sono solo degli strumenti. I media sono trattati con gentilezza, possono invadere il nostro spazio fisico, possono avere personalità che corrispondono alla nostra, possono essere compagni di lavoro, possono incarnare stereotipi di genere; i media possono evocare risposte emotive, richiedere attenzioni, minacciarci, influenzare ricordi, e cambiare l’idea di ciò che è naturale. I media sono protagonisti del nostro mondo sociale e naturale.
È un impulso naturale e incontrollabile: creare relazioni emotive con le cose è il nostro modo per comprenderle a fondo, per farle entrare nella nostra vita. È un modo per dare loro valore. Affezionarcisi per poi, quando le si perde, soffrirne. Una sofferenza della quale non sappiamo fare a meno. Perché esiste un destino peggiore della morte.
Sparire è più che morire
Racconta la Storia che durante la Guerra Suicia, la “guerra sporca” che la dittatura militare argentina condusse contro il proprio stesso popolo la gente sparisse senza una ragione. Soprattutto giovani che, si seppe in seguito, venivano caricati su aerei da trasporto e buttati al largo, nell’oceano. Una perversione che portava ai massimi livelli una delle paure più profonde dell’essere umano:quella di scomparire. Una fine contro la quale non c’è difesa, lutto o superamento. Per questa ragione non esiste nessuna civiltà che sia indifferente ai cadaveri. Agli esseri umani è necessario elaborare un rituale per comprendere e riportare sotto controllo quel tipo di abbandono, creare un sistema simbolico per segnare il passaggio, che lo immunizzi. Una necessità tanto più sentita in un’epoca nella quale la morte è così presente e nello stesso tempo inconsistente come il nostro.
E così piuttosto che scomparire milioni di utenti di Facebook, Maple Story, Word of Warcraft e tanti altri ambienti sociali vivacchiano, si sopravvivono stancamente, come in quella vita reale che il mondo virtuale ci avrebbe dovuto aiutare a sfuggire. Si cerca di condurre una vita virtuale controllata da un continuo dosaggio di discrezione ed esibizionismo, con la stessa preoccupazione di cosa dire e come dirlo che ci perseguita nella vita reale. Mal che vada c’è sempre il riposo eterno. Doloroso, certo. Seccante in molti casi, per via del tempo perduto ad arricchire quella vita di pixel. L’importante è che sia ben presente la consapevolezza che malgrado funerali commiati e rimpianti nel mondo virtuale nulla è mai davvero eterno. E che se si scompare da una parte si possa sempre ricomparire da un’altra parte con una vita tutta nuova.