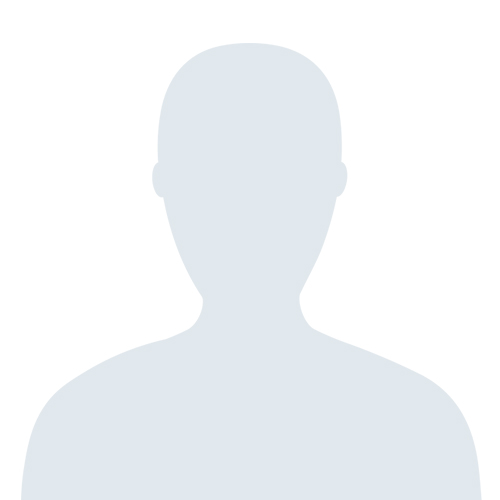Sulla domanda se costi meno Linux o l’offerta Microsoft ci si può accapigliare fino alla fine dei secoli senza arrivarne a capo. Immancabilmente, nel primo round i fautori di Linux sciorinano con lo zelo dell’evangelizzatore i soliti ben noti vantaggi: costo di licenza zero, sostanziale immunità ai virus, sicurezza, stabilità e facilità di manutenzione. Dall’altra parte si ribatte a volte a colpi di propaganda, a volte a colpi di tecnicismi, e a volte per fortuna con un po’ di obiezioni sensate, come quella che nel migrare a Linux bisogna tenere conto dei costi di formazione del personale, della necessità di abbandonare (salvo accrocchi) Office e Internet Explorer, che sono gli standard di fatto con i quali bisogna essere compatibili, e della mancanza di driver per tante periferiche.
Nel secondo round entra in gioco l’ideologia: si argomenta che Linux è libero da condizionamenti commerciali ed è la rivincita dell’Europa contro l’imperialismo americano (o del consumatore contro la multinazionale), la disponibilità del codice sorgente è necessaria per non creare dipendenze da un singolo fornitore o pericoli per la sicurezza aziendale o nazionale, e così via. A questo punto chi sostiene Microsoft non ha nulla da controbattere, perché sono considerazioni più che giuste, ma in realtà non ha bisogno di dire nulla. Sul piano commerciale ha già vinto la discussione.
Nessuno dei punti a favore di Linux, infatti, è davvero convincente per coloro che davvero decidono se adottare il sistema operativo di Linus Torvalds o quello di Bill Gates. Le aziende non ragionano sulla base delle ideologie o delle tecnologie, ma sulla base della convenienza economica, perché i sani principi sono una gran bella cosa da mettere nel depliant aziendale, ma non ingrossano i bilanci; Worldcom insegna. E gli stati, sotto sotto, si comportano allo stesso modo.
L’ufficio acquisti (aziendale o governativo poco importa) è esperto in acquisti, non di tecnologia informatica, e del destino del consumatore o del mondo occidentale non gliene potrebbe fregar di meno. Ragiona in termini economici, ed è suo dovere farlo. Parlargli di Linux in termini tecnici o ideologici è una perdita di tempo. Ecco perché al rappresentante Microsoft basta mormorare “Software Assurance” e il mantra budget prevedibile per stravincere la partita.
Il risveglio del ragioniere
Ma allora come si spiega questo fiorire di annunci di migrazione a Linux? Numerose aziende e interi governi hanno dichiarato l’intenzione di mollare Microsoft in favore di Linux: dal Perù alla Norvegia, dalla Germania alla Finlandia, passando per Corea, Thailandia, Filippine, Francia, Taiwan, Cina e Regno Unito, come raccontato da IDG.
Semplice: sono quasi tutte intenzioni, appunto. Per l’ufficio acquisti, infatti, Linux non è un trionfo dell’autarchia tecnologica. Non è neppure un buon sistema operativo. È qualcosa di molto più prezioso (dal suo punto di vista): finalmente un potenziale fornitore alternativo a Microsoft. Una carta da giocare per convincere Microsoft a offrire il proprio software a condizioni più convenienti.
Ci si è resi conto, infatti, che si può avere il beneficio economico di Linux (la riduzione dei costi) senza gli oneri associati alla migrazione. Basta fare un bel bluff. Quando si presenta il rappresentante Microsoft per negoziare il contratto di fornitura, gli si fa credere che se non offre delle condizioni più che vantaggiose si passerà a Linux. Così si ottiene quello che sotto sotto vogliono tutti (Windows e Office), ma a prezzi più bassi. Si badi bene: non è necessario migrare davvero, basta dare l’impressione di volerlo fare. Due comunicati stampa ben piazzati e il gioco è fatto. Massimo risultato, minimo sforzo.
È un bluff che funziona, perbacco. Quando il Messico ha annunciato l’intenzione di migrare all’open source la propria infrastruttura informatica, per fermare il progetto Microsoft ha accettato di iniettare circa cento milioni di dollari nell’economia del paese. Nel Regno Unito, l’annuncio del governo di voler sperimentare l’open source ha indotto Microsoft a ridurre il costo delle licenze per circa mezzo milione di impiegati statali, facendo risparmiare ai contribuenti 150 milioni di dollari in tre anni.
Dopo l’annuncio del Bundestag tedesco di voler passare a Linux, Microsoft ha rinegoziato i propri contratti, e il Bundestag ha accantonato il progetto prima ancora di iniziarlo. In Perù Microsoft se l’è cavata per ora con sconti meno drastici, elargendo soltanto mezzo milione di dollari ma arricchendo l’obolo con una visita personale di Bill Gates al presidente peruviano, che non s’è lasciata sfuggire l’occasione politicamente inestimabile di posare per una foto cerimoniale insieme a zio Bill.
La pelle dell’orso
In altre parole, i roboanti annunci di migrazione in massa a Linux vanno presi con molta cautela. Non sono certo quelle brecce nei bastioni del monopolio Microsoft che il mondo linuxiano vuol credere che siano: lo saranno quando dagli annunci si passerà ai fatti. E di fatti, per ora, ce ne sono davvero pochi. Nessuna amministrazione nazionale si è convertita all’open source, e nel mondo aziendale Linux è adottato da quattro gatti (gatti di prestigio, per carità, ma sempre quattro).
Certo fa male rendersi conto che Linux è stato usato semplicemente come pedina negoziale sacrificabile, buona solo per ottenere uno sconto dalla concorrenza. Ma occorre essere realistici. Linux, e più in generale tutto l’open source, non sono ancora pronti a sostituire il software commerciale in un’intera infrastruttura aziendale o governativa. Si sono fatti passi avanti enormi, ma ammettiamolo: se Linux va benissimo sul lato server, sul lato client in ufficio è tuttora una raffinata forma di tortura tramite deprivazione.
Forza, amici. Riconosciamo di esserci lasciati incantare dai politici e dai guru aziendali, schiodiamoci dal tavolo dei festeggiamenti prematuri e rimbocchiamoci le maniche. C’è ancora tanto lavoro da fare.