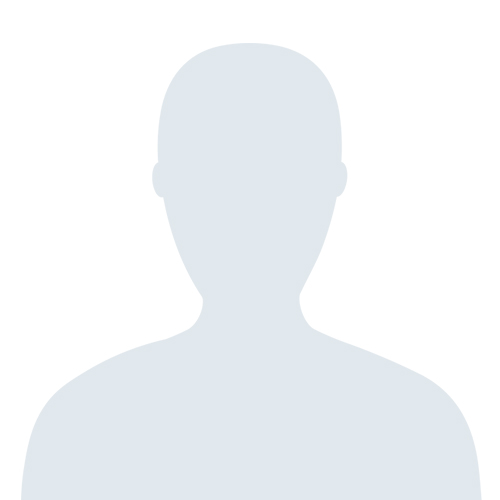Quando, a seguito dell’avanzata americana in Sicilia, il fotografo Robert Capa poté assistere ai disastri della guerra nella piccola roccaforte di Troina ebbe un rimorso di coscienza professionale. «Non aveva molto senso questo combattere, morire, scattare fotografie». Neanche la conferma del tanto desiderato incarico per la prestigiosa rivista Life era riuscito a mitigare la sua tristezza. «Avevo sperato e pregato di ricevere questa notizia per lungo tempo. Ma ora che era arrivata non ero felice». Era il 1943, l’alba del giornalismo-spettacolo, delle immagini pubblicate a poche ore dagli eventi, che avrebbe portato la guerra in diretta, dal Vietnam al Medio Oriente, dal Golfo all’Afghanistan. All’alba di quel mondo (che poi è “questo”) il più grande fotoreporter dell’epoca si pone delle domande alle quali non sa opporre che una amara perplessità. Chi ci faccio io qui, con la macchina fotografica in mano?
Depressi
Mai come di questi tempi sento i miei colleghi del mondo digitale ripetere domande e affermazioni del tipo: “sono stanco di questo lavoro”, “per quale ragione ci agitiamo tanto se poi quelli non capiscono?” (quelli sono alternativamente i clienti e gli utenti). In genere queste affermazioni sono il prologo di un discorso più ampio che va a parare sul significato della vita. Insomma, che mestiere è il nostro? Mica siamo medici che salviamo la vita o ingegneri che costruiamo ponti. Perché lo prendiamo tanto a cuore se dai nostri mouse non dipendono vite umane o i destini delle nazioni? Anche un apicultore o un idraulico hanno un posto ben definito in questo organigramma universale. Insomma , nel parcheggio dell’Arca, nessuno di noi avrebbe il coraggio di gridare. “Fatemi salire! Sono un mago del social networking e ho cinquecento follower su Twitter!”. A un muratore basterebbe sventolare la cazzuola per vedersi aprire le porte della salvezza.
C’è un bel po’ di rassegnazione nell’aria, come in un matrimonio che troppo ha lasciato ai meccanismi quotidiani e che ha perso colore e sapore. Ma questa sfiducia non è soltanto legata alla futilità di quello che stiamo facendo. È frutto di una ben più egoistica consapevolezza: noi digitali non stiamo lasciando un segno. Una latente consapevolezza nel fatto che quello che si sta facendo con tanta fatica e abnegazione creativa e manageriale vada a finire in un prematuro dimenticatoio ci perseguita. Persino quelli che hanno cominciato dal basso, che hanno affrontato e vinto la scalata verso clienti sempre più grandi e prestigiosi non sono riusciti, tuttavia, a scrollarsi di dosso la sensazione di indifferenza.
Il fatto è che quelli che fanno il mestiere della comunicazione e in particolare quelli che sgambettano nel brodo digitale vivono una contraddizione. Da una parte sono figli e nipoti di una storia di eternazione: i nostri progenitori cronisti, ritrattisti, pubblicisti e persino architetti e scultori di monumenti hanno lavorato per glorificare, diffondere, ricordare e in qualche caso eternare le glorie del proprio committente. Lo hanno fatto influenzando, piegando, riurbanizzando il mondo contemporaneo a immagine e somiglianza. Hanno aiutato i grandi (e anche i medi e a volte i piccoli) della terra a lasciare un segno più o meno duraturo. In alcuni casi l’opera eternante ha avuto benefici più sull’autore che sul soggetto. Desiderio segreto di ogni creativo. È successo con Nicholas Lanier gentiluomo dimenticato a favore del suo ben più noto ritrattista Antoon Van Dyck. O il principe Balthasaar Carlos e il pittore Velasquez.
Memoria collettiva
Quei volti, le storie, i monumenti funebri, persistono nella memoria collettiva. E qui sta il secondo termine della contraddizione. Noi digitali lavoriamo su un terreno che non è per nulla durevole e alla memoria collettiva non rimane granché da ricordare. Il mondo virtuale è evanescente e non lascia segni tangibili e come tale questi segni danno l’impressione di essere facilmente eludibili. Di fronte a degli obbrobii monumentali o al cenacolo di Leonardo che perde lucentezza non sembra poter essere scampo dal prendere posizione. Mentre ciò che accade nel mondo digitale è sempre un po’ più traballante, passeggero. Basta aspettare un po’, far finta di niente e tutto passa. E scompare. Per questa ragione quasi nessuno si preoccupa del decadimento e della scomparsa delle realizzazioni digitali. E come creativi e strateghi occidentali questo è frustrante. Non è nostra la cultura che, come quella tibetana, disegna nella sabbia per poi subito distruggere e dimenticare. Noi siamo gente del marmo, della stampa, delle torri d’acciaio e cemento armato. Restare con un pugno di mosche dopo un incauto reset è brutalmente frustrante.
Qualche tempo fa ci ha provato una costola di Amazon, Alexa a ricordare qualche cosa. Lo ha fatto con la Wayback Machine raccogliendo la memoria dei siti realizzati dalla fine degli anni novanta catturandone istantanee casuali. E così si può andare a vedere com’era il sito Apple il 15 luglio 1997o quello di BBC l’11 luglio 1998. Ma per lo più è come guardare l’album di quando avevamo scoperto la Polaroid e tediavamo la famiglia con ritratti men che casuali. Niente di cui andare particolarmente fieri. Manca l’essenza di quel che facciamo: l’interazione. Quella è andata perduta per sempre.
Dobbiamo convivere con la certezza che anche quando abbiamo la fortuna di tirar su un piccolo capolavoro di comunicazione, ci è negata la possibilità di potercene vantare con i posteri (o anche solo con quelli che conosceremo dopo qualche settimana). E così le mie figlie avranno un compagno di scuola figlio di architetto che potrà indicare un casermone pavesato di biancheria al sole e dire “quello l’ha fatto papà”, mentre loro, le mie eredi, tenteranno ancora una volta di spiegare con iperboli, metafore ed esempi che cosa ha fatto il papà negli ultimi quindici anni. Tutta roba fatta della sostanza dei sogni che si è sciolta per sempre nel cosmo.
Fare i conti
Ecco perché la prima generazione dei creativi digitali, quelli che hanno lottato contro l’indifferenza, la diffidenza e una tecnologia approssimativa cominciano a fare i conti con la propria esistenza. Non siamo più giovani scapestrati con magliette No Future. Sfoggiamo ciuffetti di capelli bianchi e ci troviamo a parlare di figli da portare a scuola. Qualcuno è già anche morto. Prematuramente, certo. Ma intanto… E così, scrivendo questo articolo di fronte alla porta di una sala parto in attesa di conoscere due nuove bambine corredate con un metà dei miei geni, mi viene da pensare che con sto benedetto lavoro non sto lasciano nulla di biecamente concreto di cui andare fiero. E comincio a capire gli sfiduciati. E persino quelli che insistono a convincermi che stiamo lavorando dentro un premio Nobel, Internet. Così, tanto per poter dire un giorno, a quelle ragazze, “sapete una volta papà ha vinto un premio, ma mica uno qualunque…”.
Robert Capa alla fine non ha risolto il suo dilemma e ha continuato a fare foto. Dopo Troina si è lanciato con i paracadutisti, ha partecipato allo sbarco a Salerno e si è infilato nella prima ondata dell’assalto al Omaha Beach, Normandia, durante il D-Day. Ha continuato così a scattare foto pensando che forse quel che facciamo è più leggero della realtà, più inconsistente di tanta materia ma che forse un po’ di senso ce l’ha. E mi piace pensare che se Robert Capa non fosse stato ucciso da una mina in Indocina avrebbe continuato a rischiare la sua vita per scattare fotografie. Perciò anche noi, gente digitale, possiamo continuare ad alzarci la mattina a pensare a qualche altra diavoleria che vivrà lo spazio di un mattino e verrà dimenticata senza lasciar tracce. Qualcosa, a qualche parte sono sicuro resterà comunque.