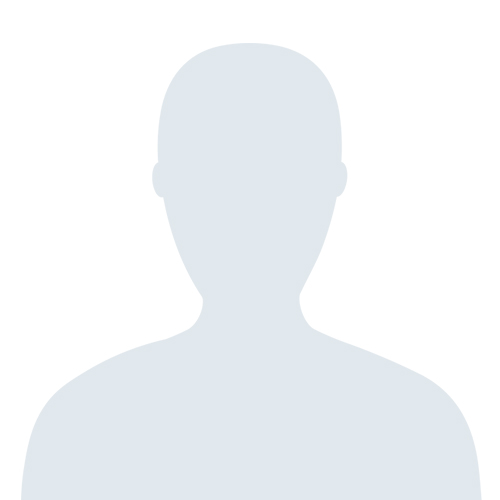Le differenze culturali tra i modelli proposti da Google+ e Facebook hanno a che fare con l’idea di socialità e con la conseguente immediatezza nel riconoscere con chi condividere contenuti: l’idea delle cerchie, ad esempio. Sembrano quindi trattare la privacy in modi culturalmente diversi. Eppure, guardando meglio, ci troviamo di fronte alla stessa prospettiva culturale del significato da attribuire all’essere online: tu devi essere online con la tua reale identità, cioè con il tuo nome vero.
Pseudonimi
È questo il principio che Google+ sta proponendo con forza, cancellando i profili di tutti coloro che non si registrano con il proprio nome reale. La policy recita: «To help fight spam and prevent fake profiles, use the name your friends, family or co-workers usually call you». Il che significa l’abolizione di nickname e pseudonimi, oltre di nomi non standard che contengono caratteri linguistici diversi, Ascii eccetera. Questa regola ha dato vita a una guerra degli utenti che va sotto il nome di Nymwars (contrazione di pseudonym wars) e ha generato un dibattito pubblico che ha fatto di questa policy la cartina di tornasole del rapporto tra vita online e logiche di mercato, tra identità ed esperienza. Cory Doctorow spiega chiaramente che si tratta di una politica che incarna
una teoria controversa sull’identità: le nostre vite sarebbero vissute in modo migliore se avessimo una singola identità persistente in ogni contesto nel tempo, così i tuoi nonni avrebbero la stessa esperienza di te che ha la persona che ami, il tuo capo vedrebbe lo stesso lato di te che vede tuo figlio.
Modelli
E non rispondetemi che basta creare le giuste cerchie o settare la privacy dei contenuti in modo oculato. Oppure, come fa Google, che uno non è obbligato a iscriversi. Qui stiamo discutendo di un modello sociale online di costruzione dell’individuo che viene imposto e del suo futuro come modello dominante nei social network e oltre: abbiamo tutti i diritti di parlarne e di cercare di capirne le conseguenze. Prendiamo per ora il rapporto fra forma dell’esperienza online e rete di friend. Opensource Obscure è il nome da avatar su SecondLife di un utente italiano che ha il profilo sospeso e che ci spiega la contraddizione che legge nella policy di G+: «È l’unico modo in cui sono conosciuto su internet. I Community Standard di Google dicono di “usare il nome con cui normalmente ti chiamano i tuoi amici, la tua famiglia o i tuoi colleghi” e nel mio caso è “Opensource Obscure”. E tuttavia il mio profilo è tuttora sospeso a causa del nome che ho scelto».
La sua riconoscibilità su internet passa dal suo pseudonimo, che è ricco di storia, di relazioni, di contenuti prodotti e condivisi. Vale la pena di ricordare che una piattaforma come Second Life obbliga a scegliere i cognomi dell’avatar entro un set di cognomi fittizi definiti, promuovendo, di fatto, l’anonimato o il semi-anonimato come policy di ingresso. Siamo di fronte a un conflitto razziale: abbiamo moltissimi potenziali utenti di una piattaforma (Second Life) trattati come migranti che devono cambiare il loro nome per entrare nella civiltà (Google+) abbandonando i nomi tribali della loro comunità per accettare di essere naturalizzati come cittadini del nuovo mondo.
Vita online
Ma poniamo anche che il nome Opensource Obscure sia fonte di una scelta razionale, non mi interessano le motivazioni che lo hanno portato a scegliere uno pseudonimo per stare in rete. Quello che conta è che la vita online di Opensource Obscure deve essere cancellata e ripartire dall’era di fondazione di G+, un’era che dovrebbe essere più autentica e reale, secondo la visione un po’ distorta di Google. Molti di coloro che hanno commentato la naming policy si sono concentrati sui problemi di riconoscibilità e distinzione di un nome reale da uno inventato che spesso porta ad accettare nomi falsi (come nel caso di Violet Blue) o sul fatto che in alcuni paesi è possibile cambiare legalmente il proprio nome, con conseguenze su una modifica successiva dell’account, oppure sull’esistenza contemporanea di nomi diversi in contesti diversi (magari sei Lady Gaga per il pubblico, ma gli amici ti chiamano Stefani Joanne Angelina Germanotta, o magari accorciano anche il tuo nome “reale”).
Si tratta certamente di obiezioni sensate che mostrano la complessa relazione tra identità e identificazione, ma presuppongono comunque una riconoscibilità in qualche modo pubblica dell’individuo attraverso il suo nome. A mio parere invece il problema va più in profondità, alle radici, come dicevamo all’inizio, del nostro modo di risiedere in rete e di utilizzare la rete. La prospettiva che emerge dalle policy di Google+ è chiara: la forma di evoluzione della civiltà, nella sua propaggine digitale, sta nell’abolire l’anonimato. L’anonimato è una delle forme su cui si è costruita la cultura internet. La possibilità di produrre e distribuire informazione e costruire conversazioni e forme comunicative online dietro a un nickname fa parte delle radici del nostro modo di stare in rete.
Chat
Ad esempio le comunità Irc ci hanno mostrato come le persone preferissero avere un nome de plum online, che era però un elemento identitario e identificativo forte del soggetto anonimo. Infatti usare il nick di un altro rappresentava un tabù che dava vita a veri e propri processi pubblici e autodafé. Oppure pensiamo alla mitologia sorta attorno agli pseudonimi nella cultura hacker. È così che ci ricordiamo ancora un phreaker come Captain Crunch, che ha diffuso un sistema per aggirare le compagnie telefoniche negli Stati Uniti – scoprendo per caso che il fischietto omaggio dei cereali Cap’n Crunch, emetteva un suono con la frequenza giusta per telefonare gratis – e che è riuscito a farsi passare al telefono il Presidente Nixon comunicandogli una grave crisi nel Paese: «Siamo senza carta igienica, Signor Presidente».
Oppure pensiamo alle radici della storia personale di Julian Assange, ideatore di una forma di wikileakscrazia, che affondano dietro lo pseudonimo da hacker che aveva assunto a 16 anni: Mendax. È Mendax a scrivere alcune regole base della cultura hacker: «Don’t damage computer systems you break into (including crashing them); don’t change the information in those systems (except for altering logs to cover your tracks); and share information». Come dire: l’anonimato online ha sì a che fare con le forme dell’identità che gli individui assumono, ma è un affare che va oltre la dimensione personale. Non è solo una diffrazione del sé, ma un principio culturale che da subito si connette alla libertà di residenza digitale e di propagazione dell’informazione.
Anonimato
Non sempre dobbiamo confondere l’anonimato con forme di inganno, truffa o insicurezza dell’abitare i territori digitali. Al contrario, possiamo pensare all’anonimato digitale come una forma di resistenza dell’individuo a tutta l’assoluta trasparenza e sovraesposizione cui le piattaforme ci assoggettano, rovesciando la prospettiva dell’essere sicuri dalla visibilità assoluta a una visibilità celata: io se voglio sono il mio nick.