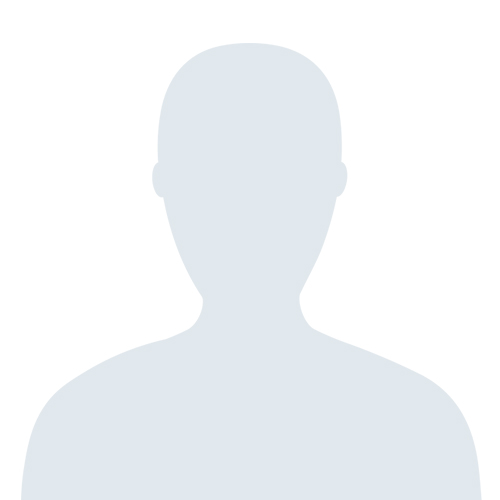In molti, quando un paio di settimane fa il guru del free software Richard Stallman ha espresso la sua soddisfazione per «la fine dell’influenza negativa di Steve Jobs sul mondo del software», hanno pensato che il vecchio Richard avesse perso una buona occasione per stare zitto. Però un po’ bisogna capirlo: dopo una vita spesa a lottare per le libertà digitali, il panorama che oggi si trova davanti è un mondo di software proprietari, e la stessa internet è ben lontana dall’essere quella promettente prateria di anarchia creativa che sognava. È, piuttosto, una rete fatta in maniera crescente su misura per le imprese, in cui le logiche del mercato sono riuscite a imbrigliare e addomesticare ciò pareva per sua natura infinito e sfuggente perché in continuo mutamento. E stanno imponendo le loro leggi, nel cui computo non entrano considerazioni di tipo etico o politico.
Patto sociale
I legislatori statali sono impossibilitati a regolare fenomeni per loro natura sovranazionali, e sono troppo lenti: una volta che avessero raggiunto il consenso su una proposta per regolamentare internet, la rete sarebbe già andata oltre. Perciò, come ha detto qualche mese fa Luca Ascani, Ceo di Populis e uno dei soli tre italiani invitati all’e-G8 voluto da Sarkozy a Parigi, «su Internet le regole le fanno le aziende». Che sono sempre più potenti e sempre meno: Amazon da sola ospita sui suoi server migliaia di siti che dipendono dalla sua infrastruttura per la loro stessa esistenza. Microsoft, Facebook, Google, Yahoo!. Più qualche altra di minori dimensioni. Stallman non è solo nella sua disillusione e nel timore per la piega che sta prendendo la rete: uno dei papà di quest’ultima, Sir Tim Berners-Lee aveva cercato di risvegliare le coscienze lo scorso anno con un pamphlet su Scientific American intitolato Long live the Web – A Call for Continued Open Standards and Neutrality.
Nell’articolo, Berners-Lee se la prendeva soprattutto con chi aveva tradito i principi fondanti il patto sociale del cyberspazio: l’accesso garantito a tutti i contenuti per chiunque disponesse di una connessione, indipendentemente dalla lingua parlata, dal conto in banca, dall’etnia di appartenenza e da eventuali disabilità. Il sorgere di giardini recintati come Facebook, in cui i contenuti postati sono riservati soltanto agli iscritti e non scandagliabili dai motori di ricerca e il comportamento di alcuni provider, che hanno deciso d’arbitrio di limitare la banda destinata a particolari utilizzi – leggi file sharing – erano alcune delle cose che davano particolarmente fastidio al grande scienziato britannico. Ma l’appello di Berners-Lee, dopo le debite attestazioni di stima da parte dei giovani miliardari divenuti tali facendo proprio quello che lui aveva stigmatizzato, fu lasciato cadere nel nulla. Arrivava tardi: i mercanti avevano già invaso il Tempio. Il che non significa naturalmente che non esista più la libertà su internet; il web è talmente vasto che nessuna corporation, o nessuno Stato, può dominarlo del tutto.
Frammenti
Quello che i grandi gruppi commerciali sono riusciti a fare è cambiare l’esperienza che del web ha ciascun utente: il viaggio di ciascuno verso gli orizzonti cibernetici non è più quel balzo verso l’ignoto, certo scomodo e con alcuni potenziali pericoli, che permetteva di scoprire a ogni passo gemme insospettate. Assomiglia a una gita organizzata in cui ciascuna tappa, perfino ciascuna deviazione, è pre-confezionata attorno all’utente per offrirgli un’esperienza personalizzata: contenuti tarati su quello che si è cercato e navigato sul web in precedenza, sui consigli degli amici, sui cinguettii di Twitter e sui “like”. Annunci pubblicitari che ti inseguono e che, per scoprire chi sei e quali sono i punti deboli su cui far leva per una vendita, utilizzano le enormi banche di dati accumulati da società che nessuno ha mai sentito nominare ma detengono un potere economico e politico, in senso lato, con pochi precedenti.
Società come Acxiom, che nei suoi sterminati data center situati in Arkansas conserva circa 1.500 frammenti di informazione per ogni appartenente a quel 96% di americani (e mezzo miliardo di persone nel resto del mondo) da lei catalogati: dal numero della carta di credito, all’indirizzo, ai debito accumulati, ai gusti sportivi alle opinioni politiche, alla patente di guida e molto altro ancora. Lo racconta con grande dovizia di particolari il giornalista e attivista Eli Pariser, che sull’argomento della personalizzazione della rete ha scritto un intero libro, The Filter Bubble. Nel primo capitolo cita il caso di una ricerca effettuata con Google da due persone di estrazione e visione del mondo simili, entrambe residenti nel Nord Est degli Stati Uniti. L’oggetto della query era lo stesso: la macchia d’olio versata dalla British Petroleum nel Golfo del Messico, ma mentre la prima navigatrice fra i primi risultati otteneva link a notizie sul disastro ambientale, alla seconda venivano proposte soltanto notizie sugli investimenti finanziari dell’azienda. Anche il numero totale di risultati era differente.
Bolle individuali
Google era impazzito? Niente di tutto ciò: nonostante quello che credono molti non addetti ai lavori, da tempo l’algoritmo di Mountain View ha cessato di essere un arbitro freddo e imparziale. E precisamente dal 4 dicembre 2009, quando un post sul blog societario annunciò l’avvio della personalized search. A partire da quel giorno, Google avrebbe usato 57 “segnali” (oggi sono molti di più), dal luogo di connessione al tipo di browser, alle ricerche precedenti, per scodellare risultati su misura. La motivazione di fondo è la medesima di quella offerta da Facebook per spiegare come mai, se si hanno migliaia di amici, nella bacheca degli utenti vengono evidenziati soltanto i post provenienti dalle persone con cui si interagisce di più o che paiono avere i nostri stessi gusti: dare alla gente quello che vuole. Evitare i contrasti. Tutto molto bello, in apparenza, e finché si tratta di scoprire gruppi musicali che probabilmente ci vanno a genio, visto che piacciono anche al nostro contatto.
Il punto, spiega Pariser, è che questo rischia di rinchiuderci in bolle in cui ciascuno vede solo la parte del web che è stata selezionata per lui da curatori invisibili. Una parte concepita come uno specchio perfetto di quella che qualcun altro ha individuato essere la nostra personalità digitale, e in cui non c’è spazio per il confronto, il dialogo, l’imprevisto. Il monito di Pariser ha alcune caratteristiche in comune con quello lanciato l’anno prima da Jaron Lanier nel suo You’re not a gadget. Ma se entrambi vedono il rischio dell’appiattimento dell’isolamento e della banalizzazione di un web che ha tradito le sue radici, l’autore della “bolla filtrante” va oltre. L’idea di vezzeggiare e rafforzare con contenuti ad hoc le convinzioni di un certo navigatore può portare a effetti perversi: se il motore di ricerca sa, ad esempio, che chi è alla tastiera è una persona povera o illetterata, gli fornirà i contenuti che ritiene adatti: chi naviga potrebbe non venire nemmeno mai a conoscenza dell’esistenza di determinate opportunità economiche o culturali.
Terreno comune
In un mondo che si informa sempre più attraverso il web se all’elettore che ha sempre votato democratico o repubblicano (o, in Italia, Berlusconi o Pd) vengono nascoste le voci dissonanti, quelle che potrebbero mettere in discussione le sue convinzioni e magari aprirgli gli occhi su determinati problemi, come sarà possibile trovare un punto di terreno e di conversazione comune? Alla fine, è lo stesso spazio pubblico che ne viene logorato. E se il palinsesto del quotidano che leggo su Facebook è composto dagli articoli più letti dai miei amici e da quelli prediletti dagli iscritti al network nel loro complesso, è probabile che nel mio stream non comparirà mai quel disturbante e noioso articolo sulla siccità in Somalia. Che, magari mi avrebbe reso più consapevole come cittadino e come essere umano, ma impallidisce e scompare davanti al didietro di Belèn che di certo fa più audience.