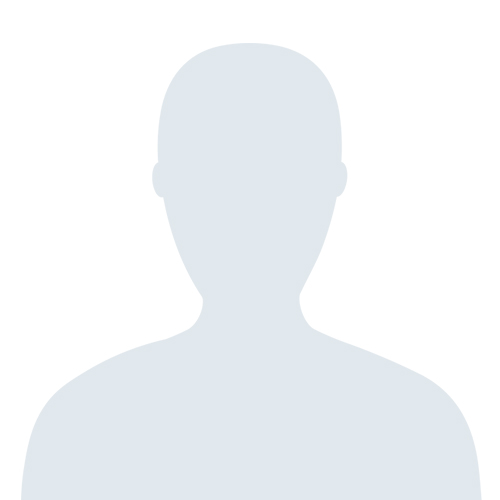Qui ci sarebbe da fare polemica, come sempre capita quando parliamo di pubblicità (o, più correttamente, di comunicazione – magari integrata). Un’attività umana di quelle che, se fatte seriamente, non possono prescindere da una attenta osservazione della cultura, dei costumi, delle persone. Tutti ambiti che stanno cambiando, con strappi, con divide, con polarizzazioni di una metà dell’Italia che è su internet e un’altra metà che non c’è. Una metà di addetti ai lavori ed entusiasti che respirano la Rete e i nuovi fermenti culturali/comportamentali. Ma anche stuoli di altri italiani (inclusi svariati milioni che magari sono anche su Facebook) che vivono la Rete in modo culturalmente più asettico, come strumento di cui si servono ma da cui non accettano lezioni di sradicamento culturale, che vivono felici un’esistenza 1.0.
Evoluzioni sociali che coinvolgono pesantemente anche il mondo dei media e quindi della comunicazione, degli strumenti per raggiungere i propri potenziali acquirenti, del modo in cui le aziende devono ragionare per essere appetibili, di nuovi sfoghi per i proprietari dei mezzi per recuperare revenue pubblicitarie che nella crisi si sono azzoppate e oggi bisogna ritrovare inventandosi cose nuove.
Cambiare marcia?
Dove stia andando la comunicazione ancora non è dato saperlo. Al di là delle dichiarazioni e delle intenzioni di molti, quel che conta è la sostanza che apparirà sui nostri schermi, nella nostra vita quotidiana. Se avete l’abitudine di leggere un qualsiasi sito, blog, rivista di pubblicità e dintorni, ultimamente avrete fatto il callo all’infinita discussione di dove dobbiamo andare. Le posizioni sono variegate: si va da chi sostiene che in fondo la pubblicità deve solo evolvere un pochino come linguaggi e soprattutto recuperare efficienza all’interno delle agenzie (già stressatissime sul fronte dei compensi e dei costi) rendendo l’organizzazione più snella e le persone più liquide e liquefatte.
All’estremo opposto chi sostiene che la pubblicità è un morto che cammina e che il creativo che non è digitale sta facendo i famosi cinque passi di Kill Bill. Se andiamo però a distillare l’essenza del meccanismo, non si può ciurlare nel manico. La comunicazione, le agenzie e le persone che vivono di essa riescono a stare vivi, nel medio periodo, solo sulla base di quanto business riescono a generare per i propri clienti. Lo so, è un’affermazione dura, ma anche la più raffinata operazione di branding, di engagement, se presto o tardi non si riflette in benefici sul bilancio aziendale è una perdita, non un investimento. Se mi permettete dunque di semplificare come al solito, la comunicazione deve servire, per sopravvivere. E forse i primi a cui deve servire sono i riceventi della pubblicità, quelli che oggi fa sfigato chiamare “i target”.
A che cosa serve?
A che cosa serva poi la comunicazione è un altro bel pasticcio. L’assioma classico della pubblicità come servizio alle persona attraverso l’informazione in fondo è sempre a suo modo valido. Grazie alla mia comunicazione, dice l’azienda, ti faccio sapere cose su di me, sul mio prodotto, su che cosa puoi farci… che altrimenti non sapresti. Replica il lettore attento: ma posso sapere di te mille altre da un numero infinito di persone, siti, blog che parlano di me, dei miei prodotti, che fanno Ucg, che fanno User Generated Marketing. Se anche è vero che un’azione di comunicazione pilotata dall’azienda spesso è preziosa per innescare più rapidamente la conversazione in rete, vero è anche che in certi casi (non in tutti) questa conversazione – in grado di orientare fortemente le vendite e la percezione – si innesca comunque.
L’altro assioma era quello di costruire una marca in uno scenario in cui gli intangibili sono più preziosi dei tangibili, immediatamente imitabili o quasi. Ma non siamo più (solo) nel mondo in cui lo spottone col testimonialone magicamente definisce un’immagine di marca che spacca i mercati. L’immagine di marca oggi si crea attraverso l’interazione quotidiana con l’azienda, l’esposizione ripetuta a messaggi aziendali e popolari. Un Vietnam da conquistare metro per metro. Il vero assioma, oggi, è che una buona parte delle persone, normalmente quelle più colte e benestanti, riconosce alla comunicazione un ruolo: quello di interrompere. O quanto meno di chiedere attenzione. Un’attenzione che solo pochi estremisti, in fondo, si sentono di negare a 360 gradi. Un virale coinvolgente, un sito intelligente, un visual mozzafiato, ammettiamolo, prima o poi ci hanno distratti dalla nostra vita quotidiana e portato a dare retta a una marca. Ma la mera creatività, la capacità di stupire e basta ormai non serve più.
Servire, non servire
Quello che serve, credo, è servire. Un marketing utile. Per poter essere ancora accettati, lo sappiamo, dobbiamo entrare nella logica della conversazione – magari non agita (con l’accento sulla i), ma un approccio in cui parliamo e siamo pronti a parlare. E, sappiamo anche questo, non c’è modo migliore per ammazzare per sempre una conversazione di quello di far perdere tempo, di non servire. Questo lo dobbiamo evitare, altrimenti passeremo da unparadigma in cui la marca serve alle persone (nel senso che entra nelle loro vite, e insieme si fanno cose belle) al paradigma in cui la marca serve le persone (nel senso di servo, mal pagato, bistrattato,sostituibile). Meglio dunque iniziare a far qualcosa subito e servire, prima di essere serviti su un piatto d’argento, come portata in un banchetto che rischia di smembrare chi non serve.