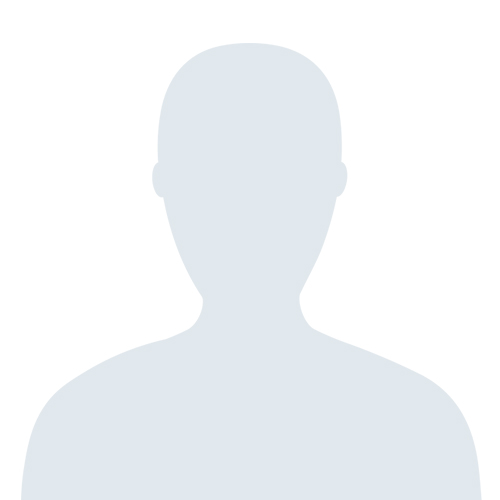Nei giorni scorsi è finito nel mirino dell’antitrust europeo l’accordo pubblicitario fra Google e il concorrente Yahoo!, che configura una situazione di quasi monopolio sulla pubblicità online. Se Yahoo! presenterà le pubblicità di Google, che fine farà la concorrenza e la possibilità, per gli utenti, di scegliere? Anche la World Association of Newspapers si preoccupa della scarsa possibilità di scelta che un accordo del genere, per quanto limitato all’ambito nordamericano, lascerà al mercato.
Ma non sarà che ci svegliamo un po’ tardi? Qualche giorno fa il New York Times ha raccontato la storia di Dan Savage, che si è visto interrompere di colpo un business fiorente da un improvviso e non meglio spiegato cambio di algoritmo di Google. Savage aveva messo in piedi un grande affare: con la sua directory Sourcetool.com aveva ideato un brillante meccanismo che sfruttava i due principali strumenti pubblicitari di Google, AdWords e AdSense. Con il primo, comprava parole chiave per far comparire il suo sito su Google. Con il secondo veniva pagato da Google quando qualcuno, dal suo sito, cercando le medesime parole chiave, cliccava su un annuncio. Siccome la differenza fra pagato e ricavato era a suo vantaggio, Savage contava su guadagni mensili dell’ordine delle centinaia di migliaia di dollari. Improvvisamente, però, in seguito a un incremento di costo per AdWords per il suo sito, le visite calano e il netto non è più a suo favore.
La spiegazione di Google, prima legata a una presunta qualità del suo sito in rapporto a non meglio precisati mutati criteri degli algoritmi interni, poi sempre più vaga (fino a suggerirgli di rivolgersi a un altro servizio di pubblicità), rivela il punto: non c’è nessun altro servizio di pubblicità che possa equivalere quello di Google per il signor Savage. Dunque Google ha deciso la sua fortuna e la sua sfortuna, in maniera opaca e senza alcuna possibilità di far qualcosa. E perché non esistono altri servizi paragonabili? Perché Google occupa la fetta di gran lunga più grossa. Perché è il migliore, il più bravo, quello con gli algoritmi che funzionano meglio o solo perché ha le idee vincenti: ma fatto sta che ogni sua iniziativa toglie inevitabilmente spazio vitale a qualunque concorrente, innescando un circolo vizioso (o virtuoso, se siete Google).
Il problema non si presenta solo nella pubblicità. Uno studio recente di Anselm Spoerri evidenzia che Google ha un impatto decisivo su quali sono le pagine più viste in Wikipedia. Non in Knol, suo prodotto: ma su un prodotto “neutrale”, esterno, come Wikipedia. Dunque ha un impatto diretto su che cosa e come veniamo a sapere le cose. Lungi dal limitarsi a questo, il meccanismo per cui nelle ricerche di Google Wikipedia (spesso meritatamente) compare ai primi posti, ha conseguenze indirette, di nuovo, sugli investimenti pubblicitari: con meno posti “liberi” in cima ai risultati di ricerca, alcuni siti possono essere spinti a investire di più nelle AdWords. Neutralità degli algoritmi? Un mito per le anime belle.
Google dà, Google toglie
L’aspetto interessante è che tutti questi fenomeni avvengono per effetto di algoritmi migliori, o comunque percepiti come più utili dagli utenti. Cioè per effetto di meccanismi di semplice concorrenza. Se il migliore (quello che gli utenti premiano come tale) vince, che c’è da lamentarsi? Non è forse il mercato? Il problema è che si generano dei meccanismi a spirale, per cui il migliore fagocita tutto e decide anche di faccende che non c’entrano direttamente con gli algoritmi. Lo stesso comportamento, messo in atto da un soggetto non dominante, non ottiene lo stesso effetto, nemmeno in proporzione.
Il fatto che Firefox contenga un keylogger, per esempio, non indigna (quasi) nessuno. Il keylogger invia dati a un servizio di ricerca, in modo che sulla base di ciò che digitiamo ci vengano forniti suggerimenti sulle ricerche in tempo reale. Ma se un simile keylogger lo implementa Chrome di Google, beh, i risvolti sono più paurosi. Perché Google ha un sacco di altri dati su di noi: e può incrociarli con ciò che digitiamo più e meglio della Mozilla Foundation (che tuttavia ha in mente un suo servizio simile, per gli incroci di dati).
Allora il punto è che i rischi sono sempre gli stessi, i comportamenti anche, e sono probabilmente tutti leciti fino a prova contraria. Persino un keylogger è perfettamente legale, anche se ci può “rubare” password e dati sensibili. Però se uno diventa il “migliore”, per suoi meriti, nel fare tutto, allora non rimangono spazi. Non rimane possibilità di scelta. E se essere il migliore aumenta conseguentemente le capacità di investimento, per gli altri non rimarranno che le briciole, mentre il “migliore” può fare tutto, e meglio, e sempre di più. Per di più con utenti soddisfatti, che non si lamenteranno e non faranno alcuna “rivoluzione”.
I ricchi diventano sempre più ricchi?
Ci sono insomma tutte le premesse perché si verifichi quello che i ricercatori chiamano preferential attachment, cioè il fenomeno per il quale chi ha di più otterrà sempre di più in termini di risorse (anche chiamato fenomeno rich get richer). In effetti questo fenomeno è sostanzialmente naturale in situazioni di rete, come i sociologi Barabàsi e Albert, e altri prima di loro, hanno suggerito. E dà vita a eventi il cui andamento segue funzioni di potenza (simili a quella della coda lunga, per capirci), per cui pochi soggetti in cima alla distribuzione ottengono molte più risorse degli altri, che gravitano nella parte centrale e poi nella coda della distribuzione.
La questione non va confusa con l’effetto “San Matteo”, come a volte viene chiamato. Nell’effetto San Matteo, infatti, chi appartiene alla coda della popolazione in esame, viene spolpato, privato anche di ciò che ha, come nella parabola dal vangelo di Matteo. Il paradosso è che nei fenomeni derivati dal preferential attachment anche chi sta in fondo alla coda può beneficiare di parte delle risorse. Non viene spogliato. è la proporzione fra chi ha di più e chi ha di meno che aumenta a favore di chi ha di più. E di conseguenza aumenta a dismisura il suo potere, pur se una piccola quota di ricchezza, di risorse, è garantita addirittura a un numero maggiore di soggetti (quelli della coda lunga, appunto), che non hanno però alcuna reale possibilità di competere davvero.
Non è forse questa la sostanza della critica di Anita Elberse alla teoria della Coda Lunga di Chris Anderson? Non che la teoria in assoluto non sia giusta. Ma che, contrariamente a quanto sperato, le conseguenze siano meno positive per la coda che per la testa. Ecco perché Google diventa sempre più forte, più potente. A quanto pare, se i ricercatori hanno ragione, la ragione è connaturata ai fenomeni e agli effetti di rete. Il problema è che questo fa piazza pulita non dei concorrenti, che possono sempre partecipare e raccogliere le briciole. Ma di ogni ipotesi di concorrenza seria, concreta: cioè che minacci il primato di chi sta in testa alla coda. Insomma, se questo è vero, e Google (o chi per lui: le leggi di potenza non guardano in faccia nessuno) viene lasciato crescere senza limiti, semplicemente non si potranno più avere alternative, se non in nicchie che potranno anche essere relativamente remunerative, ma che non arriveranno mai alla dimensione tale da mettere in discussione Google.
In cerca del lieto fine
Quello che potrà succedere sarà l’emergere di un nuovo ambiente, di una nuova forma di rete, su cui si sposteranno nuovi servizi, nuovi comportamenti, nuovi mercati, che renderanno obsoleta o meno rilevante la posizione dominante del soggetto coinvolto nella rete precedente. È fantascienza apocalittica? Forse. A guardare il mercato dei media in altri settori, però, pare proprio quello che succede ogni volta, in assenza di regolazioni.
Che sia per questo che Tim Berners Lee si è fatto, beato lui, una nuova, discussa fondazione per regolamentare un po’ il web?… La parola regolamentare suona sinistra, nella terra delle libertà virtuali. E certo molto dipende da quale tipo di regolamenti si partoriranno. Il rischio concreto che i regolamenti a fin di bene siano dei cavalli di Troia per limitazioni di libertà sacrosante ci sono tutti. Ma se, almeno in linea di principio, qualche ragione ce l’avesse pure lui?