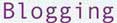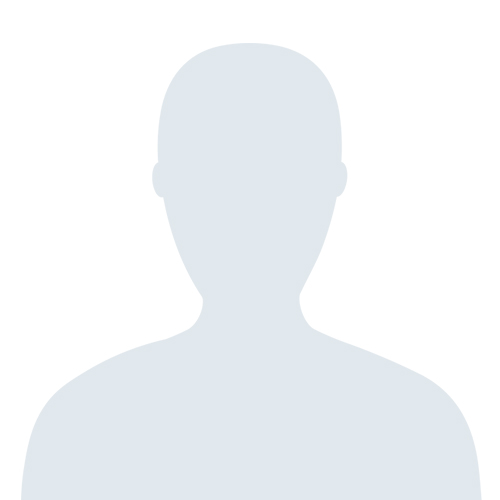Da sempre, uno dei motori pulsanti del digitale è la libertà d’espressione. Un filo rosso che fa da collante alle molteplici incarnazioni di internet in questo suo trentennio, o poco più, di vita. È sulle ali del “free speech” che, ad esempio, nel 1978 Ward Christensen e Randy Suess creano a Chicago il primo Bulletin Board System (BBS), chiamato CBBS, in italiano definite “bacheche elettroniche”. [Per chi non c’era o avesse dimenticato, textfiles.com raccoglie un enorme archivio di file testuali risalenti a quell’epoca, oltre a elenchi di BBS d’ogni tipo e altro materiale storico a dir poco vitale, con annesso documentario video in lavorazione sul mondo delle BBS]. Da quei primi esperimenti di comunicazione aperta si passa man mano a progetti più sofisticati ma comunque devoti alla comunicazione interpersonale: conferenze, mailing list, comunità virtuali, e, ultimo in ordine di tempo, il fenomeno weblog (meglio noti come blog). Dove si riaffermano le potenzialità trasversali di una libertà d’espressione tanto fondamentale quanto spesso data per scontata e finanche sopraffatta dal dilagare dell’internet più biecamente commerciale.
Non è quindi un caso che la libera circolazione delle idee veicolata dai molti blog odierni rimbalzi perfino sulle testate mainstream, e che anche la politica se ne arricchisca e anzi ne stimoli la propagazione. Rimanendo allo scenario statunitense, di questi tempi ciò significa innanzitutto la trasmissione online di informazioni, notizie e quant’altro atto a spingere il diretto coinvolgimento dei cittadini-elettori. È il caso, manco a dirlo, della campagna presidenziale per il 2004, dove recentemente hanno fatto spicco le iniziative online di uno dei nove candidati democratici, Howard Dean. Il cui weblog ufficiale è stato infatti impostato fin dall’inizio come uno strumento per creare comunità piuttosto che vetrina per mettersi in mostra. E il cui manager, Joe Trippi, non fa mistero di affidarsi ad un modello tipo open source o software libero onde costruire aggregazione dal basso. “Ogni casa che si cerca di fare su internet viene completamente soffocata se si tenta di controllarla o comandarla”, ha spiegato l’ex- dirigente di Progeny Linux Systems.
Pur se ancora agli albori, soprattutto nella politica online, simili esperimenti di attivismo orizzontale — in assenza di un comandante in capo e minimante filtrati o organizzati – vanno riaffermando la vitalità del free speech e dell’attivismo di base. Non a caso, secondo il professor Lawrence Lessig, questa di Dean sembra rivelarsi la prima “campagna presidenziale open source”. Il sito offre in pratica una serie di opzioni per stimolare la gente comune a partecipare in prima persona, per (cercare di) riappropriarsi di una politica da tempo esautorata unicamente a favore dall’establishment. E creando un contesto favorevole allo sprigionarsi di scintille per varie forme di attivismo sul territorio, come pure per l’arrivo di contributi d’ogni tipo, non ultimi quelli economici. Anche se è d’uopo una buona dose di prudenza: “potrebbe anche non funzionare, c’è sempre tempo per inciampare in qualche ostacolo” aggiunge lo stesso Lessig.
Rimandando a prossime uscite per ulteriori approfondimenti, il tutto testimonia una chiara rivalutazione, anche a livello quasi-istituzionale, della piena circolarità del pensiero libero offerta, quando non proprio garantita, dal medium digitale fin dai suoi albori. Qualcosa che, se pare funzionare per una cerchia di utenti/attivisti, continua invece a stridere con le tendenze repressive di alcune agenzie governative. Non si tratta qui di insistere con argomentazioni sacrosante ma ormai note (almeno in questo spazio) sulla tutela dei cyber-rights o sui nefasti effetti di legislazioni quali il Patriot Act e il DMCA. Stavolta la mania repressiva ha colpito — meglio: ci ha provato — niente meno che il diritto-dovere dei giornalisti a informare i propri lettori. Ecco i fatti: qualche settimana addietro l’ufficio FBI di New York ha intimato a Declan McCullagh, corrispondente di CNet, di “preservare tutti i dati e le prove” relative alle sue interviste con Adrian Lamo, il cosidetto ‘homeless hacker’ accusato di recenti intrusioni nei sistemi infornatici del New York Times. Come non manca di sottolineare lo stesso giornalista nel portare allo scoperto la vicenda, il bello è che la richiesta viene basata sull’Electronic Communication Transactional Records Act, a sua volta fondata su una clausola del DMCA, in cui ai provider si impone di conservare simili dati per un periodo di 90 giorni in attesa della richiesta del giudice.
Ma poiché ciò si applica solo agli “Internet service provider, non ai reporter”, occorre forse chiamare in causa la stupidità degli agenti FBI? Oppure ritenere che quest’ultimo sia “out of control”? Risate a parte, McCullagh arriva però rapidamente al punto: la lettera dell’agenzia si fa beffe della tutela alla libertà della stampa garantita dal primo emendamento alla costituzione. Ovvero, citando le sue parole: “Chi avrebbe fiducia in un reporter che non fosse altro che un confidente dell’Attorney General John Ashcroft?” Da qui la formale replica degli avvocati del giornalista (e di CNet) in cui si legge tra l’altro che la questione “potrebbe sollevare serie preoccupazioni sul First Amendment e potrebbe risultare in un confronto costituzionale tra media e FBI.” Richiedendo infine a quest’ultimo di ritirare la richiesta e chiudere immediatamente la faccenda.
Si attende e ci si augura l’archiviazione del caso, visto che, scrive McCullagh, “ottenere delle scuse sarebbe troppo”, onde assicurarsi che ciò non abbia a verificarsi nuovamente in futuro. Ma forse c’è una lezione più complessiva: ieri come oggi e domani, occorre vegliare attentamente sui fenomeni relativi alla libertà d’espressione online — anzi meglio: farla propria e amplificarla al massimo, dalle bacheche elettroniche ai blog d’ogni tipo, dall’attivismo di strada alle campagne elettorali.