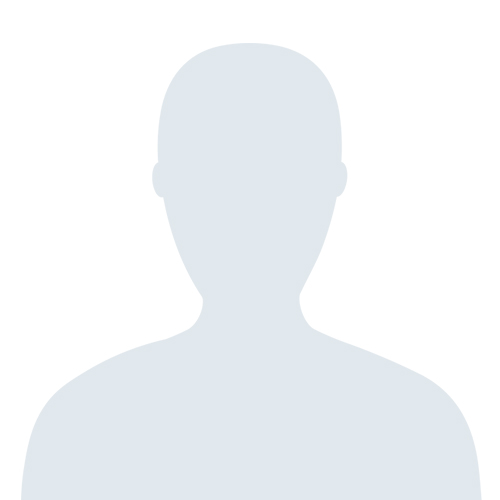La guerra in Libia sta uccidendo migliaia di civili, nello scontro tra il regime di Gheddafi e i ribelli. Anche lì i social media stanno avendo un ruolo nel continuare a diffondere informazioni, accanto ai mass media. Questo è quello che cerco di fare anche io frequentemente: lo chiamano social media journalism o mediattivismo o online news gathering. Dovremo trovargli un nome migliore. La scorsa settimana sono rimasti uccisi due famosi fotoreporter occidentali, Tim Hetherington e Chris Hondros. Le loro immagini spesso ci mostravano gli aspetti più crudeli della guerra, ce la portavano in casa e qualche volta ci spingevano a muoverci per tentare di fermarla. Il lavoro di queste persone è fondamentale, è meritevole al massimo: affrontare proiettili, granate, bombe armati solo di una reflex è degno di un eroe civile. Il 20 aprile, a Misurata, non ce l’hanno fatta.
È giusto mostrare il video?
Erano in quattro, Tim è morto praticamente subito, gli altri tre feriti gravemente, Chris morirà la stessa notte. Non è la prima volta che accade in Libia e non sono gli unici civili dilaniati ma il mondo si chiedeva in quelle ore che fine avessero fatto. Li hanno portati in ospedale, Chris appariva in condizioni disperate, in fin di vita. È a quel punto che è apparso su Facebook un lungo video girato all’interno dell’ospedale dove si vedevano due di loro feriti (Guy Martin e Chris), Tim ormai cadavere. Il video indugiava sui corpi distesi in solitudine, sulle ferite, si vedeva l’operazione in corso su uno dei tre per salvargli la vita, budella esposte, chirurghi affannati. E per ogni sequenza il nome del giornalista in sovrimpressione ben chiaro: un precario tentativo di documentare, senza dubbio. Non abbiamo forse già visto decine (o centinaia) di video del genere durante questa primavera araba? E altrettante foto, magari scattate proprio da uno di loro.
In realtà nei video di questo tipo di solito osserviamo i familiari che dolorosamente espongono i propri cari martoriati per urlare la loro rabbia al mondo, per chiedere aiuto, per fermare la follia, o lo fanno i medici per denunciare l’abisso, o lo vediamo durante azioni di guerra per renderci conto di cosa accade. Non in questo caso. Ho deciso quindi di non diffondere il video, ma di raccontarlo e basta perché non aggiungerebbe nessun valore alla notizia se non l’esposizione, tutt’altro che anonima, dei momenti più fragili e intimi di una persona ben conosciuta: la malattia e la morte. Ognuno, se vuole, avrebbe potuto trovarlo, anche se continuo a non considerarlo giusto.
L’ipocrisia di non mostrarlo
Andy Carvin, noto social media reporter di National Public Radio, decide invece di pubblicare il link, preceduto da una lunga spiegazione. È giusto, secondo lui, che si veda il video per par condicio con gli altri civili arabi di cui si mostrano quotidianamente ferite e morte. Perché questo è quello che avrebbero fatto loro come fotorepoter. In caso contrario sarebbe ipocrisia, come se il velo della privacy calasse solo sugli occidentali o sui giornalisti. Tutto ciò nonostante i loro familiari in pena fossero a 8.000 chilometri di distanza, e spero che nessuno di loro abbia visto il video con i loro nomi nonostante il disclaimer di Andy. Esiste davvero una doverosa par condicio mediatica sui feriti e sui morti o possiamo distinguere caso per caso? Ammesso, e non concesso, che siano stati fatti degli errori in passato dobbiamo ripeterli per tutti o possiamo permetterci di essere più umani online?
Perchè la differenza tra i mass media e i social media è enorme, e il giornalismo non può non tenerne conto. I primi sono gerarchici, hanno un controllo redazionale centralizzato: mostrare o meno ai telespettatori un video è una decisione essenziale perché in caso negativo nessuno lo vedrà mai e sarà perso. Ecco perchè spesso decisioni che possono sembrare crudeli, o addirittura da sciacalli, vengono prese sacrificando il privato, la pietas, l’intimità sull’altare dell’informazione. Spesso queste decisioni risultano importanti per coinvolgere l’opinione pubblica su un tema urgente e grave come quello della guerra. Pensiamo alle foto della guerra in Vietnam, e quello che hanno significato, ai soldati sfigurati, ai monaci che si danno fuoco e così via. Altre volte invece, e purtroppo sempre più spesso, questa è solo una scusa per fare notizia, per arrivare prima degli altri o vendere di più. È indubbio che l’opinione diffusa è che ormai si indugi fin troppo, riparati dallo lo scudo del diritto di informazione, nel superare ogni limite.
Media reticolari
I social media invece sono organizzati a rete, hanno un controllo diffuso: quello che faccio io è una selezione possibile delle informazioni che già sono presenti ma ce ne potrebbero essere mille altre differenti. La scelta di chi legge e partecipa si basa sulla reputazione, e quest’ultima si costruisce col tempo, con la qualità, con i fatti. Alla fine è la rete che sceglie quali informazioni meritano di salire a galla e spesso sono informazioni che sui media tradizionali non troverebbero spazio o che non avrebbero senso lì: la rete non rappresenta solo un’espansione dell’informazione tradizionale, nel senso dell’approfondimento. I due modelli, allo stato attuale, non sono alternativi e convivono stabilmente, ma usare l’approccio tipico del primo nel secondo è un errore.
La rete permette di scegliere se guardare o meno un video ma la distanza di un clic è ancora troppo poco (soprattutto su Twitter). Se pensiamo che un contenuto possa essere lesivo per qualcuno possiamo semplicemente scegliere di non proporlo. Possiamo permettercelo perchè non siamo dei canali all news, siamo dei punti in una rete, cooperiamo, non siamo isolati. Se non mostro un contenuto è perchè penso che anche i miei pari non siano d’accordo, ma forse ci sarà qualcun altro che lo farà per il motivo opposto: nei social media nessuno è uomo per tutte le stagioni. Ciononostante si può continuare a sostenere le proprie convinzioni. Forse è il momento di iniziare a immaginare un’etica e una deontologia informativa modellata per i social media. La rete ci permette di essere più vicini, di entrare in empatia e quindi di fare distinzioni. È giusto sfruttare questa opportunità per ottenere un’informazione più efficace e coinvolgente, ma più umana.