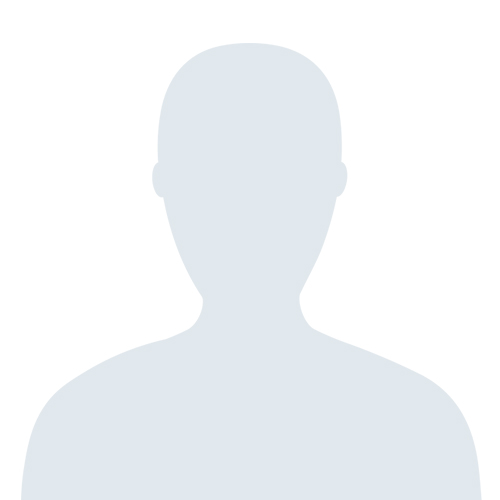Sul futuro dei giornali e soprattutto del loro modello di business, così evidentemente in crisi anche grazie alla gratuità delle notizie online, si stanno interrogando in molti. Fra i più acuti da sempre c’è Clay Shirky, docente e consulente americano che già a marzo scorso ci aveva segnalato che il modello di business dei giornali non regge, e che non si sa che cosa può venir dopo. In un recente intervento Shirky riprende e amplia il discorso con considerazioni interessanti, che da noi si sentono fare poco spesso. Il succo del suo intervento è che non tutto il giornalismo è uguale, non tutte le notizie hanno lo stesso valore e che i modelli di business per notizie di tipo diverso possono essere diversi.
Il giornalismo di maggior valore per la società è il cosiddetto “accountability journalism”, ovvero il giornalismo d’inchiesta che offre alla comunità informazioni che consentono loro di giudicare le figure pubbliche (in parole povere). E cita ad esempio l’inchiesta del Boston Globe sulle accuse di pedofilia a padre John Geoghan, che hanno costretto la Chiesa cattolica a occuparsi pesantemente del caso fino a scusarsi con le vittime, rendendo impossibile un insabbiamento o un accomodamento delle notizie. Non è difficile immaginare altri casi in cui i giornali compiano inchieste e pubblichino notizie di elevato valore pubblico, proprio perché danno ai cittadini modo di valutare l’operato di amministratori, controllori, figure con responsabilità pubbliche.
Forse in Italia non abbiamo una tradizione di “accountability journalism” così forte e indipendente: anche per una questione di limitato pluralismo delle proprietà, spesso le inchieste assumono colori politici a senso unico, nel senso che pochi si aspettano che giornali di centrodestra pubblichino inchieste su figure pubbliche di centrodestra, e giornali di centrosinistra su quelle di centrosinistra. In un paese dove il giornalismo sia di utilità sociale, queste distinzioni non ci dovrebbero essere: un giornale non dovrebbe porsi il problema di chi è colui di cui sta pubblicando le notizie.
Un bene pubblico
Se questo tipo di giornalismo è quello che produce il massimo beneficio per la società, esso è a tutti gli effetti un bene pubblico. Il guaio è che costa: a volte uno o due autori devono essere impiegati per mesi per condurre le inchieste, per produrre forse un’inchiesta o forse nulla. Solo imprese economicamente fiorenti possono permettersi un tale investimento. Da qui tutti i pianti sulla crisi dei giornali, che, vedendo erodere i propri profitti, non sarebbero in grado di mantenere la qualità delle proprie inchieste. Qualità che molti osservano in realtà smentita dai fatti: come detto sopra, le inchieste in Italia sono a senso unico, contro l’avversario politico, e spesso addirittura montate ad arte. Il che rende l’argomento dei giornali retorico per molti utenti e blogger.
Il cattivo stato del nostro giornalismo (a pochi giorni dalla manifestazione per la libertà di stampa) è dovuto però più al limitato mercato italiano e al conseguente scarso pluralismo, che spinge il giornalismo a cercare protezioni. Non elimina il valore di quelle inchieste che, talvolta, vengono comunque fatte e dunque non inficia il ragionamento di Shirky, che parte dalla situazione americana. Quel che Shirky dice con chiarezza è: attenzione, che questo modo di intendere i giornali è un’anomalia della storia. I giornali hanno potuto fare giornalismo d’inchiesta per un paio di secoli, ma solo perché godevano di una posizione di rendita indebita, acquisita per ragioni contingenti, soprattutto negli Stati Uniti, e che ora le rivoluzioni sociali e tecnologiche stanno spazzando via.
Tre condizioni
In particolare, dice Shirky, tre condizioni sono storicamente determinanti per la capacità del giornalismo di far inchiesta:
- Un relativo monopolio pubblicitario. Dalla nascita della “pennypress” fino ai grandi network commerciali, gli inserzionisti non avevano molta altra scelta che comprare pubblicità sui prodotti giornalistici per reclamizzare i propri prodotti e arrivare ad una diffusione ampia. Il ventesimo secolo, con la nascita di strategie di comunicazione complesse e la moltiplicazione di canali e piattaforme, ha reso via via questa esclusività meno importante. Ora esistono molti modi in cui un inserzionista può comunicare con il suo mercato. Internet, addirittura, ha reso evidente che non è detto che debba fare pubblicità. Può direttamente aprire un sito, finanziare un’iniziativa focalizzata sul prodotto. Era vero anche prima di internet, come coloro che si occupano di strategia e pubbliche relazioni sanno. Ma, per capirci, ora la rivoluzione è giuta al culmine: i giornali non sono più in posizione di monopolio. E dunque non c’è motivo per cui la pubblicità continui a pagare il giornalismo. Ragioni etiche? Ma il business, dice Shirky, non finanzia qualcosa per ragioni etiche. Lo fa solo se gli conviene. E ora non conviene più come prima. Certo, la pubblicità non sparirà dai giornali. Ma non si tornerà più alla redditività di un tempo.
- Oltre a pagare troppo, gli inserzionisti finora sono stati anche poco e mal serviti. Qui Shirky affronta due argomenti distinti: il primo, è che se un giornale è forte, è indipendente dall’inserzionista. Cioè può scrivere male di lui anche se l’inserzionista compra un sacco di pubblicità. Il che è un primo tipo di “servizio insoddisfacente” per l’inserzionista. L’obiezione è assai poco rilevante in Italia, dove l’inserzionista ha un potere enorme rispetto alla proprietà dei giornali, di solito, e può incidere direttamente sui contenuti giornalistici. Il secondo argomento è che può non aver senso comprare spazi specialistici su giornali generalisti: se voglio vendere una bici perché devo mettere inserzioni su un quotidiano che mi parla del tempo e del governo, anziché andare dove si vendono le bici? Anche questo argomento vale più negli Stati Uniti. In particolare perché vi era un forte mercato di inserzioni a pagamento di compravendita diretta fra privati (come i nostri la Bancarella, Portaportese, ecc.), che erano una forte fonte di sostentamento soprattutto per i giornali locali. Fonte che si è via via assotigliata con la nascita di servizi online come Craiglist. In generale però è vero anche in Italia che si può sempre più far pubblicità altrove, rispetto ai giornali. La pubblicità stessa può diventare medium. Da sola.
- Il terzo cambiamento storico riguarda una debolezza intrinseca del prodotto giornalistico: la sua incoerenza. Perché mai uno dovrebbe essere interessato a leggere notizie diversissime su un giornale? Magari è interessato solo ad alcuni argomenti e non ad altri. Il giornale per sua natura è una piattaforma incoerente. Mette le parole crociate vicino alle notizie sul tempo e alla politica estera. La gente ha ora la possibilità di andare alla fonte o di riaggregare le notizie sulla base dei propri interessi. Dunque un prodotto così ha fatto il suo tempo.
Queste tre caratteristiche dei giornali – troppo cari per gli inserzionisti, poco efficaci e incoerenti – sono debolezze che potevano resistere solo perché non c’era niente di meglio. Ora i media digitali modificano tutto questo, e dunque anche se i giornali tagliano i costi, non si rallenterà la caduta: è il tipo di prodotto a essere inadeguato. I giornali non hanno però solo difetti. Hanno anche pregi: ad esempio, quelli di propagare le notizie. Una notizia pubblicata su un giornale distribuito capillarmente in una certa comunità ha un impatto maggiore, gira, viene ripreso e rimediato, diventa patrimonio comune. La propagabilità della notizia crea valore per la notizia. Ma solo per quelle di interesse comune, dice Shirky. Ad esempio, la notizia degli scandali sessuali era già comparsa su giornali di minor peso, eppure solo quando è stata pubblicata sul Boston Globe, è riuscita a propagarsi e a mettere pressione sulla Chiesa. Ecco perché l’idea di rendere a pagamento le notizie online, rilanciata anche recentemente da Rupert Murdoch, è controproducente: certe notizie acquistano valore proprio perché circolano, soprattutto quelle di utilità pubblica come le inchieste. Mettere un pedaggio sulla loro circolazione significa distruggerne il valore pubblico.
Diverso è il caso delle notizie settoriali, come quelle economiche (non a caso le uniche per cui finora la gente è disposta a pagare, anche online: i casi del Financial Times e del Wall Street Journal su tutti; ma valgano anche i casi di banche dati specialistiche in vari ambiti, da quello legale a quello scientifico). In particolare dati di quotazioni, banche dati storiche ecc. Il valore, per queste notizie, risiede proprio nella loro esclusività. Nel fatto che bisogna pagare per accedervi. Questo porta a dei vantaggi a una piccola comunità che su questo fonda il proprio lavoro. Non è un modello applicabile alle notizie comuni, non a quelle di pubblica utilità.
Alternative
Shirky nota che la rapida diffusione delle notizie, ieri garantita solo dai giornali, oggi è possibile anche direttamente con i media elettronici (campagne di mail di segnalazione, video virali ecc.). Certo, quello che i giornali, soprattutto quelli grandi, possono mettere in campo è la loro autorevolezza. Il marchio, che spinge a considerare con una luce diversa quello che pubblicano. Non è infatti detto che spariscano. Ma il modello di business che consente di produrre giornalismo d’inchiesta o di pubblica utilità viene comunque messo in crisi. Quali alternative, per il giornalismo di pubblica utilità? Questo tipo di informazione può essere prodotta sostanzialmente in tre modi:
- sul mercato
- con il sostegno di finanziamenti pubblici
- per produzione sociale.
Internet facilita enormemente la produzione in gran numero di campi, ma in particolare quelli non afferenti al mercato. Internet in effetti limita un gran numero di modelli di business, e crea le condizioni per potenziare la produzione basata sul servizio pubblico e sulla collaborazione sociale.
Dunque, ci troviamo di fronte a una rivoluzione. Non dobbiamo rimpiazzare i giornali. La natura del capitalismo, secondo Shirky, è di premiare i prodotti che hanno successo e di far sparire quelli che non ce l’hanno. Dobbiamo però trovare altri modi per produrre le medesime informazioni di beneficio pubblico che finora erano state prodotte dai giornali. È chiaro che questo non accadrà rapidamente. Anzi: Shirky si iscrive chiaramente nel partito dei realisti/pessimisti. O comunque si distacca con forza dagli utopisti e dai tecno-ottimisti: la distruzione del modello di business dei giornali sarà più rapida dell’emersione delle alternative. Perciò potremmo trovarci in una fase di involuzione in cui i benefici pubblici di un certo tipo di giornalismo – quello che serve alla convivenza civile e alla democrazia – non ci saranno. Quindi potremmo trovarci di fronte ad un’involuzione democratica.
Invece di spendere tempo a salvare i giornali, dovremmo investire energie nella sperimentazione di nuovi modi di produzione (che coinvolgano il sostegno pubblico o la produzione sociale) di informazioni socialmente utili. Solo da queste sperimentazioni, nasceranno i nuovi modi per la produzione dell’equivalente del “giornalismo d’inchiesta”. Ma nessuno sa quanto potrebbe volerci.
Se la piattaforma paga il contenuto
Tutto questo discorso, di rara chiarezza, arriva in Italia – dove la situazione è diversa, e dunque tempi e modi del declino potrebbero essere diversi – proprio mentre si inizia a discutere su un input di Carlo De Benedetti, editore del gruppo Repubblica-L’espresso. L’idea è di finanziare la fruizione gratuita delle notizie online con una parte dei ricavi della connettività alla rete da parte dei gestori telefonici.
Quest’idea non è nuova. È solo sempre stata accantonata, perché non suonava realistico chiedere ai fornitori di connettività di stornare parte dei propri ricavi per destinarli ai produttori di contenuti online. Se ora si torna a parlare di questa ipotesi senza scandalizzarsi è forse segno che ci si è resi conto che le alternative (micropagamenti, modello iTunes ecc.) sono del tutto irrealistiche. La proposta si fonda su un assunto: dalla nascita della rete a oggi, non sono i produttori di contenuti ad aver guadagnato, come si immaginava fin dal 1996, anno dell’articolo di Bill Gates “Content is King”, ma i fornitori di connettività. E con guadagni consistenti. Sarebbe del tutto legittimo stimare quanta parte di questi guadagni dipenda dai contenuti messi liberamente online. E riconoscere agli autori una parte. Il modello non è diverso da quello delle piattaforme satellitari: si paga l’accesso a un mondo di contenuti al gestore tecnico, il quale storna ad alcuni canali parte dei ricavi, per i contenuti.
I problemi rimangono molti. Bisognerebbe evitare che i ricavi andassero solo ai grandi gruppi, anzitutto, escludendo i contenuti generati dagli utenti, dai non professionisti o dai non appartenenti a gruppi mediatici. Bisognerebbe poi bilanciare la prevedibile prevalenza dei contenuti d’intrattenimento su quelli socialmente più utili. Inoltre, come molti hanno notato, è facilmente intuibile come una simile proposta finirebbe per spingere i fornitori di connettività a ricaricare sul costo dell’abbonamento il ricavo da stornare. Dunque alla fine pagheremmo sempre noi.
Ma non è forse proprio un modo per “socializzare la produzione” di contenuti utili? Certo, le contraddizioni sono dietro l’angolo. Ma il giornalismo di pubblica utilità sembra messo talmente male che forse vale la pena di pensarci.